Intervista con il fondatore di Alligator su Koko Taylor
di Matteo Bossi
Avevamo parlato a lungo con Bruce Iglauer qualche anno fa in occasione del cinquantennale della sua creatura, Alligator (Il Blues n. 155). L’occasione per una nuova chiacchierata è data dalla celebrazione di un’artista legata da un lungo rapporto all’etichetta, Koko Taylor, una collaborazione inaugurata mezzo secolo addietro, nel 1975, con “I Got What It Takes”. “Abbiamo lavorato insieme per oltre trentacinque anni, sia come etichetta che come management, per un periodo sono anche stato il suo booking agent, ma per fortuna non per molto perché non ero poi così bravo a farlo. Ha accolto tutto lo staff di Alligator a casa sua, ci ha fatto sentire parte della famiglia, non era una relazione soltanto di lavoro. Ero al suo fianco quando ha scritto I’m A Woman, voleva cantarmela di persona, non al telefono, ero al suo fianco quando il suo primo marito è mancato ed ero lì quando è mancata lei. Una relazione speciale.” Queste le sue prima parole riguardo a Koko Taylor e l’antologia di fresca pubblicazione intitolata appropriatamente Crown Jewels, una selezione di dodici tracce dal suo catalogo.
Come vi siete conosciuti con Koko? Era una sera in cui cantava ospite di Mighty Joe Young, come hai scritto nel tuo libro, Bitten By The Blues.
Doveva essere il 1972, perché abbiamo pubblicato “I Got What It Takes” nel 1975 e per allora avevo già iniziato ad occuparmi del suo booking. Ma sì, cantava con Mighty Joe Young e lavorava come colf, domestica. Non come musicista professionista, in quel periodo. Non aveva nemmeno una sua band. Ci hanno presentati e mi lei mi chiese subito se potessi trovarle delle date. Cercavo di fare il booking agent di Hound Dog Taylor e Son Seals, e per questo avevo contatti con club e festival. Le dissi che ci avrei provato ma sapevo che non aveva una band, né un van o un mezzo di trasporto. Le avevo lasciato il mio numero di telefono e una o due settimane dopo mi ha chiamato dicendo, “ho già versato un anticipo per un van e sto provando con una band, ecco i nomi di chi suona”. Mi stava dicendo che, se l’avessi presa sul serio lei avrebbe fatto tutto il necessario per poter fare un bel concerto. Non abbiamo parlato di un disco allora, ma c’era l’idea che potesse incidere per me. Era molto affidabile e non si aspettava certo che facesse queste cose per lei. Non ci sono molte persone così. Suo marito era il guidatore e quando ho parlato al suo funerale ho detto che sarebbe stato ricordato da amici, parenti, famiglia e fan e da dozzine di poliziotti della stradale che hanno visto le sue luci sparire in lontananza! Guidare a 100 miglia orarie (160 km/h ndt) era normale per lui.
Era già stata in Europa un paio di volte.
Sì, sapevo che ci era stata nel 1967 o ’68 con Little Walter all’American Folk Blues Festival e poi a Montreux dove ha registrato un duetto con Muddy. E fece un disco in Francia durante uno dei tour che organizzava Didier Tricard per l’etichetta Black & Blue con Jimmy Rogers e Louis Myers. Ci siamo scritti un paio di giorni fa, siamo rimasti amici tutti questi anni. Ha avuto la possibilità di incidere e l’ha colta, non ricordo di preciso l’anno in cui è stata fatta, ma era sotto contratto con nessuno dopo la morte di Leonard Chess.
È scomparso nel 1969.
Sì, prima che io mi trasferissi a Chicago. Non l’ho mai incontrato. Prima di morire ha venduto la Chess all GRT. Dopo la fine dell’etichetta non c’erano molte opportunità e il blues ha smesso di essere parte del mainstream nella radio di musica afroamericana. C’erano ancora programmi blues, come quello di Pervis Spann, che trasmetteva 45 giri e Lp, ma il blues non era più così popolare tra i giovani neri. E stava iniziando ad essere conosciuti tra i bianchi. Quando ho dato inizio all’Alligator l’etichetta più attiva a Chicago era probabilmente la Delmark, ma pubblicava solo tre o quattro Lp all’anno. Perciò qualsiasi occasione per registrare era eccitante per i musicisti.
Come avete lavorato per il primo album di Koko su Alligator? Alle chitarre c’erano Mighty Joe Young e Sammy Lawhorne. Avete scelto insieme il repertorio?
Beh, c’erano canzoni che Koko cantava regolarmente come “Big Boss Man”…qualcuna l’ho proposta io ed altre lei. La cosa interessante è che le prove si tenevano da Willie Dixon nel South Side, vicino a dove abitava Koko, ma ero così intimidito da Willie che non gli ho parlato né mi sono consultato con lui. Ne ero intimorito, non fisicamente, ma del fatto che ne sapeva talmente più di me e se la stesse ridendo discretamente alle mie spalle. Il che potrebbe anche essere avvenuto! Per quanto riguarda la band, l’unico membro del suo gruppo regolare che abbiamo usato era Vince Chappelle, il batterista, perché all’epoca la band di Koko era quella che poteva permettersi, non necessariamente la migliore possibile…ma andava bene per i tour. E alcuni musicisti non amano andare in tour. Vince era con lei già negli anni Sessanta ed era lui che l’annunciava sul palco ogni sera, “and now the queen of the blues Kokkko Taylor!!” era bravissimo. Joe era suo amico, oltre ad essere uno dei più affidabili chitarristi ritmici in circolazione, aveva una grande conoscenza degli accordi, della ritmica e di come suonare funky, molto più della band. Sammy Lawhorne era ed è uno dei miei chitarristi preferiti di sempre. Ma ho dovuto fare un accordo con lui. Sammy era un alcolista e sapevo che doveva bere un po’ per restare concentrato, ma lo presi da parte e gli dissi che, se avesse bevuto troppo, sarebbe stato licenziato dalla session. E che doveva essere d’accordo nel bere con moderazione. Così fece e fu sempre molto bravo durante le registrazioni. Mi prese seriamente perché sapeva che ero un suo grande fan. Era un chitarrista meraviglioso, così sensibile. Lo andavo a sentire al Theresa’s e talvolta suonava seduto sul suo ampli a finiva letteralmente per addormentarsi lì sopra. Non potevo permettere che succedesse durante le incisioni. Tempo dop, durante le session di “From The Heart Of A Woman”, sembrava stesse per addormentarsi, così gli dissi, “Sammy, non puoi bere durante le mie registrazioni”. “Non sono ubriaco”, mi disse lui, “è che la notte scorsa sono stato pugnalato con un punteruolo da ghiaccio, dopo la session vado all’ospedale”. Si è sollevato la maglietta e mi ha mostrato il buco. Ovviamente non avrebbe rischiato di perdere i soldi della session andando prima all’ospedale!
Il primo disco è andato bene e poi da lì avete proceduto sempre uno per volta.
Dovevo fare così per forza, ho iniziato praticamente senza soldi…Ho dovuto vendere abbastanza Lp di Hound Dog Taylor per poter registrare Big Walter, altrimenti non avrei potuto farlo. Poi ho dovuto vendere abbastanza Hound Dog e Walter per incidere Son Seals, il che è stato un quasi un disastro, non le registrazioni in sé stesse, ma proprio perché presentare un nuovo artista era molto difficile. Con Koko sapevo che aveva una buona reputazione ma non era grande. Il primo disco è andato bene ma è stato col secondo, “The Earthshaker”, che le cosa ha preso davvero il volo. Abbiamo rifatto “Wang Dang Doodle” e il groove che usava allora era diverso, più funky e leggermente più lento dell’originale. Credo di averle proposto “Hey Bartender”, mentre “You Can Have My Husband”, il pezzo di Irma Thomas, lei lo conosceva già ma glielo avevo suggerito io. Per “I’m A Woman” stavo ascoltando Muddy Waters o Bo Diddley, non ricordo quale dei due, e pensavo che nel blues ci sono molte canzoni sull’essere un uomo, un duro, ma nessun vero inno dal punto di vista femminile. Così suggerii a Koko di scrivere una canzone in risposta a “I’m A Man/Mannish Boy”. L’idea la entusiasmava e meno di una settimana dopo mi ha chiamato dicendo, “vieni a casa mia”. Così ho guidato fin lì, che era a circa 45 minuti da me e me l’ha cantata nel suo soggiorno. Ed era finita. A volte do consigli su una rima o qualcosa da fare ma era a posto così. Sapevo che sarebbe stata grande e lo è stata, una canzone importante per lei. Dopo l’uscita del disco l’ha cantata ogni sera e ne era molto orgogliosa.
Forse non era un’autrice prolifica ma ha scritto grandi canzoni negli anni. Sull’ultimo disco cinque portavano la sua firma.
Quando abbiamo registrato l’ultimo album è stato un po’ difficile, la sua voce era stanca, erano due anni prima della sua scomparsa. Non ho incluso (su Crown Jewels ndt) brani da esso perché non ha avuto tempo di farli diventare parte del suo repertorio, ha tenuto relativamente pochi concerti dopo l’uscita. Era in ospedale e ad un certo punto era anche sottoposta a ventilazione polmonare…pensavamo non si sarebbe ripresa e invece ci sbagliavamo. Non era pronta a morire. È scomparsa nel 2009. Il primo concerto quando è uscita dall’ospedale è stato per un benefit, una raccolta fondi, non era nemmeno pagata. Era un evento creato da una famiglia per cui aveva lavorato come colf, per persone affette da una patologia, le cui ossa si rompono molto facilmente. Decise lei di farlo. E quando Koko aveva in testa un’idea la portava a termine. Era molto determinata. Non aveva studiato, non era un’intellettuale, veniva dalla campagna detto nel senso migliore possibile. Se ti amava, ti amava completamente. Se invece era arrabbiata con te, lo sapevi subito. E mi piacciono le persone così, che sono esattamente come sembrano.
David Lynch è scomparso qualche mese fa, Koko ha partecipato ad un suo film, Cuore Selvaggio (Wild At Heart), che tipo di esperienza è stata?
Davvero piuttosto divertente. Ci hanno contattati solo due giorni prima della data in cui avremmo dovuto andare in California per fare quella scena. Dovetti assumere un avvocato per rappresentare Koko nelle trattative, perché sapevo potevano venir fuori dei bei soldi. E stava letteralmente ancora negoziando mentre io e Koko stavamo andando all’aerporto. Concluse l’accordo e una volta arrivati in California, Angelo Badalamenti, il compositore che Lynch apprezzava molto, ci ha portato direttamente all’hotel per provare il pezzo. La canzone venne incisa il giorno dopo con un gruppo di musicisti jazz che lei non aveva mai visto. Mi sembra che Jimmy Heath fosse al sax tenore, non ricordo chi fosse il tastierista, ma era il leader della band. E quello stesso giorno o il seguente eravamo sul set e lei ha cantato per la scena in cui Nicolas Cage e Laura Dern ballano nel bar. Ricordo solo una lunga attesa. Lei aveva imparato la canzone solo la notte prima ma era pronta. È successo tutto in fretta. Hanno suonato la canzone per intero e poi nel film ne hanno usato solo un pezzetto. Era entusiasta e decisa a farlo al meglio possibile. Ma del resto prendeva seriamente ogni concerto. Sapeva di dover fare un gran lavoro, capiva l’importanza dell’occasione. Durante una pausa sul set ero seduto accanto a David Lynch e si mise a parlare di come viene ammazzato il bestiame nei macelli di Kansas City. Insomma, parlava di vacche morte, in qualche modo era appropriato. Era preso dal portare avanti il film, non aveva molto tempo da dedicarci, ma fu molto gentile.
Come avete lavorato sui dischi successivi? C’è stato qualche altro punto di svolta?
Abbiamo aspettato un certo lasso di tempo tra un disco e l’altro, a parte quello dal vivo che era il suo show abituale e non ho cercato di influenzarlo con nuove canzoni. Credo ce ne sia solo una, “The Devil’s Gonna Have A Field Day”. Mi ricordo di quando ha portato Criss Johnson alle session di “From The Heart Of A Woman”, ero davvero nervoso perché non lo avevo mai incontrato e non sapevo cosa potesse portare. Sapevo che era essenzialmente un chitarrista gospel, forse una volta l’avevo visto con Otis Clay. È stato un fattore importante nel cambiamento del suono, più funky. È un chitarrista straordinario. L’ho incontrato qualche mese fa al funerale di Gene Barge. Suona solo in chiesa e agli spettacoli gospel. Era molto raro per lui suonare cose che non fossero gospel, eccetto per Koko, erano anche cugini. Si rivelò una bella aggiunta per la band, faceva cose interessanti per gli arrangiamenti, cose che non mi sarebbero venute in mente. Quella session con lui e Sammy Lawhorne fu grande. Sammy era cresciuto in campagna e poi aveva suonato con Sonny Boy, Muddy, Junior Wells…Criss era musicista più sofisticato, un grande chitarrista ritmico. Non avevo mai capito, per esempio, che i chitarristi ritmici non suonano sempre tutte le corde insieme, ma si adattano al pezzo. Io ho provato a suonare la chitarra ma sono davvero scarso e non lo dico per fare il modesto. Oltretutto suonava da mancino con le corde rovesciate perciò non era facile seguire le sue mani. Ha fatto molto per Koko.
Nel tuo libro hai scritto che Koko ti diceva spesso, “benedetto il ponte che ti ha portato di qua”. Pensi ad Alligator come un ponte?
Beh, un ponte tra l’artista e il suo potenziale pubblico, anche se non funziona sempre. Ma quando succede puoi creare una carriera per un artista che duri tutta la vita, come per Koko. Sto lavorando al nuovo album di Lil’Ed & The Blues Imperials e credo sia il nono o decimo insieme. Lo conosco da quando non aveva neanche trent’anni e ora ne ha settanta e suona ancora bene come allora, anzi persino meglio di quando era più giovane. Allora lavorava in un autolavaggio. Ora ha una casa, non sarà ricco ma finanziariamente solido. Cerco sempre di aiutare i musicisti se me lo chiedono.
Quale pensi sia l’eredità musicale di Koko?
Ho visto molta gente provare ad imitarla e fallire. È stata una grande influenza su tante cantanti emergenti. Era un’icona di quel che significa essere un’artista blues. Era indipendente. Quando Koko era contenta di una performance della band dopo il concerto si festeggiava. Se non lo era, mi cacciava fuori dai camerini, chiudeva la porta, e potevo sentire parole che in una conversazione normale non avrebbe mai usato. Sapeva essere dura con la band, era come una madre per loro, ma una madre molto severa. Sapeva come prendere il comando e diceva sempre loro di “guardare il mio piede”. Erano loro a dover trovare il suo groove e suonare la musica nel modo in cui lei la sentiva. Questo era il loro lavoro.
Koko non ha mai licenziato nessuno, ma poteva essere molto ruvida. A volte, come dire, diceva di aver sbagliato giudizio quando aveva assunto qualcuno, ma non voleva comunque licenziarli, erano diventati parte della famiglia. Aveva uno straordinario bassista, Jerry Murphy, che era legatissimo a lei, la considerava sua madre. Poi Jerry cominciò a fare uso di droghe e fu soltanto quando iniziò a non presentarsi ai concerti che si decise a licenziarlo. Ma lo ospitò da lei quando era un senzatetto. Mi ricordo un concerto, non ero lì, ma me lo hanno raccontato, in cui aveva un grosso taglio, qualcuno lo aveva colpito con un coltello per una storia di droga. Ma era una bella persona. Ha cambiato la mia percezione dei tossicodipendenti. Penso che poi ne abbiamo perso le tracce. Quando è arrivato il crack è stato un grosso problema, prima girava più che altro alcohol.
Koko poteva davvero farti sentire un membro della famiglia. Lo ha fatto anche con Shemekia. Le piaceva anche perché Shemekia non ha mai cercato di cantare come Koko. Era gentile con tutti, fino a che scopriva di non potersi fidare di qualcuno. Perciò all’inizio eri senz’altro nelle sue grazie e dovevi metterti d’impegno per cadere. Una volta mi ha licenziato come suo manager, eravamo su un volo internazionale. Mi ha riassunto quattro ore dopo e sono state quattro pessime ore.
C’è un progetto che ti sarebbe piaciuto fare con lei e per varie questioni, magari di tempo, non si è concretizzato?
Ci sto pensando. Sarebbe stato bello fare un album di duetti, con uomini e donne. Mi sarebbe piaciuto sentire Koko cantare con Ruth Brown per esempio. L’ho conosciuta un po’, Shemekia ha registrato una canzone con lei. Siamo andati a Las Vegas per la registrazione e lei è stata deliziosa. Penso sempre che gli artisti non abbiano i riconoscimenti che meritano. L’unica apparizione di Koko sulla TV nazionale fu durante i Grammy quando fecero un tributo al blues, con B.B. King, Albert King, Robert Cray, Dr John, Junior Wells, Willie Dixon, Etta James…la si trova su Youtube. Credo alla batteria ci fosse Jim Keltner e Tim Drummond al basso, più qualcun altro. La cosa interessante, come nota a margine, stavano suonando una sorta di Tulsa groove, poi Robert Cray ha cantato la sua parte e iniziato a suonare la ritmica, l’intera band gli è venuta dietro e il groove è cambiato completamente. Ero lì e l’ho sentito. Sto cercando di ricordare se fosse andata anche al primo Soundstage quando fecero un tributo a Muddy.
Era nel segmento di Chicago, “Godfathers & Sons”, della serie prodotta da Scorsese.
Sì, ma non ero contento di questo. Il creatore di quel film aveva deciso di voler mostrare la connessione tra blues e hip-hop. La parte buona di tutto questo è che filmarono una jam con un sacco di artisti al club che Koko aveva in quel periodo, c’erano Magic Slim, Detroit Junior, Lonnie Brooks…era vero Chicago blues. Quei film avrebbero potuto essere qualcosa di importante per il blues, ma era il periodo dell’invasione dell’Iraq…li mandarono in onda in serate consecutive e se non sapevi nulla del blues diventava probabilmente troppo confuso da seguire, tutti registi diversi, un peccato e un’occasione mancata. Ma non si può stare a lamentarsi per quello che non ha funzionato.
Ci sono state altre opportunità di avere la sua musica in film o serie televisive?
Se veniamo contattati per una serie tv o un film cerchiamo di spremere loro tutto quello che possiamo e poi accettiamo. Ma non ci sono state altre occasioni con Koko. Non posso ricreare il passato. Sono ancora stupito che questa cosa creata nel mio monolocale duri ancora oggi. E continui a lavorare con alcuni degli stessi artisti, come Lil’ Ed. E, come allora, i dischi nascono durante le prove, è lì che prendiamo tutte le decisioni. In due giorni in studio abbiamo registrato sedici tracce di base, poi è tornato per sistemare le parti vocali. Ma devo fare dischi in fretta, altrimenti non stiamo nel budget, ed è l’unico modo che una etichetta come la nostra possa sopravvivere.

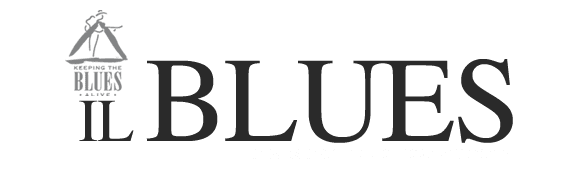











Comments are closed