Un brivido lungo la schiena, inquietante come la notte e un cerbero alle calcagna. E’ questo che trasmette l’ultimo disco di Tinsley Ellis, un’altra volta solo, con la sue chitarre e una voce potente, che non è scontato, posseduta dagli spiriti del Delta, dal falsetto alla Skip James fino al ringhio alla Son House.
E poi “squadra che vince non si cambia”, visto che anche il suo precedente “Naked Truth” del 2024 era (per la prima volta) un disco acustico, oggi candidato ai Blues Music Award, dove Ellis fu solito esporsi senza orpelli elettrici su brani che ogni chitarrista, a dirsi completo, riproporrebbe anche live, nel suo lato “senza spina” o (come si diceva negli anni Novanta) “unplugged”.
Una veste acustica, che è pure la vera identità dei pezzi e che soprattutto nel blues, invita ogni musicista all’essenzialità d’un genere povero: sicché “a togliere” e come ancora aggiungeremmo noi, dal nostro idioma letterario (ma ci vorrebbe il giusto corrispettivo americano in ambito musicale) a “sciacquare i panni in Arno”: in tal caso, come sarebbe di molti “… in Mississippi”.
E’ lì lo snodo e al contempo il richiamo, per chiunque si dica figlio di cotanti padri, nella migrazione che dalle chitarre acustiche giunse a cavi e riverberazioni elettriche, finanche a farsi forte nella strada all’indomani delle dobro d’acciaio.
Imbracciando così la sua National resofonica, ma anche un mandolino e le sue Martin a sei e a dodici corde, Ellis fa le cose come si deve e dopo l’esperienza del progetto precedente (con un tour attraverso gli States, per scherzo soprannominato “two guitars & a car”) rivisita ancora la sua idea, stavolta con blues autografi, conditi di quella percezione primigenia che neppure manca di questi tempi, in risposta a quel che (o a chi, piuttosto) riporta gli Stati Uniti ai secoli bui, di quando nacque il blues.
E scende davvero, Ellis, in pausa da queste registrazioni, a bagnarsi dell’acque fangose “a battesimo nel Grande fiume”. Sino al Padre delle acque, quali padri furono i bluesmen come il sopravvissuto Jimmy “Duck” Holmes, che Ellis decide davvero d’incontrare proprio nel mentre della gestazione di “Labor Of Love” (Alligator) e – “una volta tornato a casa …” – dice – “… sono tornato subito in studio e ho incorporato tutto ciò che avevo sperimentato nella mia musica”.
Il risultato è quest’album, che affonda più del precedente nelle “muddy waters” e ti trascina via nelle correnti limacciose, dove se l’anima non affoga, allora lo spirito è blues. Così è il battere del piede su “Hoodoo Woman” al cuore della canzone, viva quanto dura il beat incessante sul legno della veranda; il boogie di “Long Time”, cui manca solo l’ animalesco abbaiare “aoh aoh aoh” dell’ipnotico incedere alla Hooker.
Ci sono poi “Sad Sad Song” come “Too Broke” o “Lay My Burden Down”, che sembrano attingere a piene mani dai fantasmi degli hoboes al limitar della massicciata; o il “Bentonia – style” che tradisce l’autentico insegnamento “a bottega” (per intenderci, al Blue Front Café) di Jimmy “Duck” Holmes, con “I’d Rather Be Saved” in primis, quindi “The Trouble With Love” prima, così “Fountain Love”, dopo. In mezzo, la potentissima “Sunnyland” che resuscita Son House e ci piace ancor più delle altre. Al secondo capitolo, la svolta acustica di Ellis ce lo distingue qual musicista ancor più che in elettrico, ed è un gran disco.
Matteo Fratti

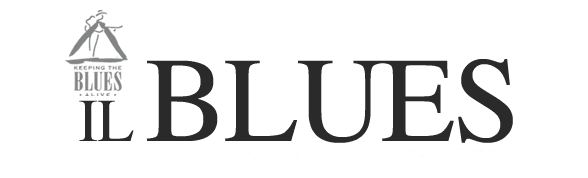









Comments are closed