“Si è vero mi sono ritirata tre anni fa, ma c’era la pandemia e nessuno era in tour, perciò credo tutti abbiano pensato…oh OK, certo, come no.” Ci scherza su JJ Thames quando le diciamo che siamo ben contenti ci abbia ripensato riguardo al ritiro. La incontriamo prima del soundcheck della sua tappa milanese, in questo tour europeo è accompagnata dalla solida e dinamica band dell’ottimo Luca Giordano. La sua carriera l’ha portata dal nativo Michigan in giro per varie città americane, oggi vive a Las Vegas, a mettersi alla prova con musiche diverse fino ad abbracciare fino in fondo il blues e il soul. Ora che è tornata sembra più determinata cha mai a lasciare il segno, “il disco che pubblicherò il prossimo anno mi rappresenterà davvero a pieno titolo”, aggiunge lei.
Il tuo viaggio nella musica è stato, per così dire, non lineare, eppure forse proprio per questo più interessante. Sei cresciuta a Detroit e la musica ha sempre fatto parte della tua vita.
Sì, non ho iniziato nel modo in cui pensano molti. Sono figlia di un predicatore ma non ho iniziato a cantare in chiesa, ho una formazione classica, ho iniziato a nove anni a prendere lezioni e poi sono passata al jazz a quindici ed ho continuato fino all’età di circa vent’anni. A quel punto cantavo R&B o soul e ho abitato ad Atlanta, scrivevo per altri artisti. Ho avuto contatti con l’industria musicale in vari modi, ma appunto ho cominciato dalla classica e credo che sia stato un vantaggio, mi ha resa in grado di passare al blues e ad altro e viceversa. Mi piacciono generi diversi, talvolta si incontrano sul palco…la gente potrebbe esserne sorpresa di trovarsi di fronte a rock psichedelico, blues tradizionale, jazz o reggae…ma il blues è musica primordiale, è alla base di tutto, posso andare ovunque con esso.
Tuo padre è un predicatore?
Sì, ma oltre ad essere un predicatore ha lavorato alla General Motors, è andato in pensione come dirigente dopo aver iniziato come guardi di sicurezza. Siamo molto orgogliosi di lui. Dal 2003 è in pensione e nel 2000 ci siamo trasferiti a Jackson, Mississippi. Per qualche anno ha fatto avanti e indietro con Detroit. Io mi spostavo parecchio, ho vissuto a New Orleans, Atlanta e poi in Mississippi…Poi mio padre si è dedicato completamente alla chiesa, ne ha aperta una a Jackson, Mississippi, fino a poco tempo fa quando ha chiuso e si è trasferito con mia madre a Las Vegas, dove abito io. A loro è piaciuta. È una cosa di famiglia insomma.
Entrambi i tuoi dischi usciti per la DeChamp iniziano con un brano gospel. Perciò, anche se non sei cresciuta cantando in chiesa, quella musica fa comunque parte di te?
Sì, sono a mia volta un ministro ordinato, supervisiono un ministero quando non sono in tour, una comunità di discepolato cristiano. È una grossa parte della mia identità, di chi sono. La cosa buffa è che dal lato di mia madre, i nonni e i bisnonni erano predicatori, mentre dal ramo paterno, mia nonna aveva un juke joint a Emporia, Virginia negli anni Quaranta e Cinquanta. Erano i tempi delle leggi Jim Crow, lei era sul Green Book…tutti gli artisti che passavano in zona si fermavano a dormire e in cambio dell’ospitalità, del cibo e di tutto il resto, come il moonshine, suonavano e cantavano. Perciò vedi da un lato vengo da una lunga fila di predicatori e dall’altro di artisti e musicisti. Uno dei miei zii suonava la chitarra e molti cantavano…
È qualcosa che è successo spesso, santi e peccatori, sabato sera e la domenica mattina.
Sì ed io sono parte di entrambe. Mio padre è cresciuto così, ne ho parlato con lui proprio recentemente. Tutti venivano a casa giovedì, venerdì e sabato sera, sua madre preparava e cucinava…La musica è alla radice del mio essere, l’ho letteralmente nel sangue. Quando la gente mi chiede dove trovi ispirazione non so rispondere, mi alzo e basta. La musica la sento.
Puoi raccontarci di quando ti sei trasferita a Jackson e come ti sei integrata nella scena musicale locale?
Quando sono arrivata a Jackson ero molto ingenua, ma alla fine è stato un vantaggio. Non sapevo nulla anche se qualche tempo prima avevo firmato un contratto con la Warner Brothers ma era in ambito pop/R&B. A Detroit avevo una formazione classica e jazz e mi ero esibita in un club di spoken word piuttosto popolare. In Mississippi non conoscevo davvero nessuno, non avevo agganci, anche se sapevo di voler fare musica…Avevo diciotto anni, comincia a passare tempo al centro commerciale e incontrai un ragazzo. Mi chiese di uscire insieme e per San Valentino, volendo impressionarmi, mi portò in un club, Hamp’s place. Siamo entrati e ci siamo seduti ad ascoltare questa band, Mo’ Money, suonavano insieme da venticinque anni. Non avevo mai sentito nulla del genere avevano un suono così soulful! Il modo in cui interagivano…ne ero estasiata. Volevo farne parte, anche se non avevo nemmeno l’età per essere nel club. Così mi sono avvicinata e ho chiesto se potessi cantare un pezzo con loro, venendo dall’ambiente del jazz. Non sapevo che nel blues non è una cosa così abituale. Non si va a chiedere. Ma appunto ero ignara. Mi hanno guardato e hanno visto che ero una ragazzina e così hanno detto OK. Credo che il mio aspetto mi abbia aiutato quella sera! La cosa divertente è che quando mi hanno chiesto che cosa volessi cantare io ho risposto che avrei potuto cantare uno standard jazz come “Summertime”, “Misty” o “Autumn Leaves”, ma loro mi risposero di no, perché canzoni del genere non avrebbero funzionato lì. Non sapevo nulla di blues, al massimo conoscevo Billie Holiday cose come “Strange Fruit” o qualcosa di Nina Simone. Nient’altro. Allora mi hanno detto, “senti, perché non vieni alle prove martedi prossimo così lavoreremo a qualcosa”. Non avevo mai ascoltato blues.
Quindi nemmeno i tuoi genitori lo ascoltavano a casa?
No, mio padre ci è cresciuto, ma io no, ascoltavo la Carmen…i miei ascoltavano gospel o comunque christian music, tutt’al più qualcosa di Al Green. C’erano alcuni dischi o cassette che amavano e basta. In ogni modo, la settimana dopo quando sono tornata da loro, avevo scritto una canzone originale. “Ma non lo fa nessuno”, mi dissero, “devi scegliere una cover”. Ma non ne conoscevo, per questo ne avevo scritta una mia. Alla fine, l’abbiamo provata e gli è piaciuta, tanto che la sera ebbi una standing ovation. Ho continuato a cantare con loro per un mese, è stato bello essere parte di qualcosa, imparare nuove canzoni, un repertorio con cui non avevo familiarità. Un mese dopo il proprietario de club mi pagò, ecco come sono diventata parte della band. Abbiamo continuato per sei anni. Da lì ho cantato con Andy Hardwick all’Hilton Hotel, quattro sere a settimana. Ho imparato molto anche da lui, Andy aveva un curriculum notevole, aveva suonato anche con Ike e Tina Turner e molti altri, era sulla settantina e mi prese sotto la sua ala. Mi ha fatto imparare il blues, ho iniziato a cantarlo e a studiarlo, non il soul blues, proprio i classici, Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker…Andy era duro con me quando cercavo di buttarci dentro qualche elemento jazz, ma è stato un bene, ho appreso davvero a cantare una canzone. Era della vecchia scuola. Questo mi ha aperto le porte di alcuni festival. Poi ho iniziato anche a lavorare con Harrison Calloway dei Muscle Shoals Horns. Mi ha ingaggiato come vocalist per Peggy Scott Adams e molti altri artisti. Una cosa porta all’altra, l’incontro con le persone, le opportunità di concerti.
Un’altra tua amica e mentore è stata Patrice Moncell, un’ottima cantante, che avrebbe meritato di essere più conosciuta.
Quello che ha segnato molti artisti negli anni Ottanta e Novanta sono state le droghe. Tutti quelli che ho incontrato si sono raccomandati “stanne alla larga”. Proprio perché molti di loro hanno finito per avere una dipendenza che ne ha rallentato la carriera. Patrice era grande. Veniva a cantare da Hamp’s e la cosa mi infastidiva perché quando succedeva tutti mi paragonavano a lei. Magari avevo una buona serata poi saliva lei e d’un tratto sembrava che il pubblico pensasse, “OK ora non ci interessa tanto di te”. Ero arrivata al punto da sentirmi intimidita dalla sua presenza. Una sera mi sono detta, “sai una cosa, non mi importa se sei lì ad ascoltarmi, è il mio concerto e ora canto la mia canzone”. È stata la svolta. Quando è salita mi ha indicata al pubblico e dopo è venuta da me dicendo, “voglio aiutarti a raggiungere il livello successivo nel music business”. Così, ho cominciato ad andare a trovarla e lei mi ha insegnato molte cose che non si imparano a scuola, come parlare al pubblico, come creare un momento, controllare il palco…in pratica come essere una entertainer professionista. Il blues è fatto di questo. Il jazz parla di te, ma il blues per loro, il blues è per la gente.
Hai pubblicato un disco a nome Jenesis.
Sì, quello è stato il mio primo nome d’arte. Ho pubblicato un disco da indipendente nel 2007 e poi di nuovo su un’altra label nel 2011. Ero di nuovo a Detroit e lavoravo molto sia dal vivo che agli Harmonie Park Studios. Tutto a livello locale però. E mi chiedevo cosa fa sì che un musicista diventi un artista. La risposta è che occorre creare qualcosa, un corpus di lavori originali. Dovevo pubblicare qualcosa. Sono andata in studio con un produttore e ho inciso circa quaranta canzoni. Non abbiamo potuto mixarlo e masterizzarlo come avremmo voluto, ma era comunque qualcosa. Era anche un periodo buio per me, mio figlio era mancato l’anno precedente e questo disco mi diede fiducia per il prossimo passo.
Dopo hai vissuto a New York per qualche tempo.
Sì, ho lasciato Detroit per New York, era l’inizio del 2009…avevo passaggi radio e ingaggi a Detroit, ma New York era sempre stata il mio sogno, perciò decisi che fosse il momento di provarci. Era l’obiettivo. Ma niente è andato come avrei voluto. La mia situazione abitativa non era esattamente ideale. Scoprii di essere incinta di mio figlio e la cosa non era assolutamente programmata, anzi andava contro tutto quello per cui ero venuta a New York. Ci ho scritto anche una canzone “Plan B Abortion Blues”, era su “Raw Sugar”, quella che si sente all’inizio del brano è la sua voce. Tenerlo è stata la decisione migliore che abbia preso. Poi sono stata ordinata ministro in chiesa e per circa un anno ho lasciato da parte la musica, mi sono concentrata su quello e sul crescere i miei figli. Ho anche lavorato per un periodo come manager in un ristorante chiamato The Garage, che aveva anche musica dal vivo. E infine ho aperto una scuola di musica con l’intento di supportare i musicisti/insegnanti che partono in tour per qualche mese e al ritorno devono ripartire da zero e con un’altra situazione, la mia idea era appunto di ovviare a questo facendo ruotare gli studenti.
Come hai incontrato Grady Champion? Eri di nuovo in Mississippi? Hai registrato due dischi per la sua etichetta DeChamp.
È stato ad una jam al Blue Monday, che si teneva settimanalmente a Jackson. Grady è venuto e mi ha ascoltato cantare. Disse che stava per partire con la sua etichetta e voleva propormi un contratto. Pensai, “si certo, come no…e gli diedi il mio contatto”. Ma non lo conoscevo, il che è strano perché ero solita suonare al 930 Blues Club, eppure per qualche ragione non mi ricordavo di lui. Solo di Eddie Cotton. Jackson è talmente piccola che tutti dovrebbero conoscere tutti, ma non è così! Alla fine, mi ha contattato il manager, ha dato inizio all’etichetta e abbiamo inciso due dischi.
Matteo Bossi

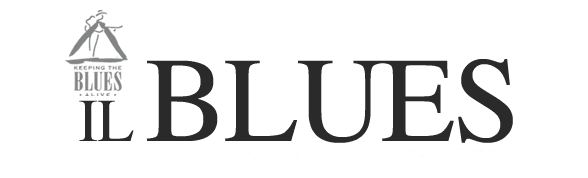









Comments are closed