Quando leggi un bel libro, vorresti ritrovarne le stesse emozioni in mille altri. Sensazione che si attanagliava un po’ tra di noi all’uscita dalla Santeria Social Club in viale Toscana questa 15 ottobre 2018, che le aspettative di ritrovare in un chitarrista poco più che ventenne dalla Carolina del Sud (non nuovo a Milano, dopo lo scorso maggio) un po’ Dereck Trucks un po’ Warren Haynes un po’ Allman, ma con tutta la genuinità degli “almost famous”, ci aveva di certo predisposti per un gran concerto, complici le attese generate dalla mole audiovisiva on line. In realtà è che bisognerebbe riservarsi sempre un po’ di sorpresa, non aspettarsi mai troppo e godersi lo spettacolo per quello che è, cosa non facile quando qualcuno esagera costruendo falsi miti intorno a nuove promesse.
Che i riferimenti di cui sopra siano comunque il “terroir” dove è cresciuto il nostro, già lo avevamo capito dai dischi in cui addirittura, nel secondo omonimo, i nomi poco sopra compaiono alla produzione e guest – stars in un paio di pezzi. Ma se i lavori a un album si fanno in diverse sedute di studio tradendone capolavori, il palcoscenico non mente, terreno di gioco ove la dimensione dal vero è quella che più si addice a tali musicisti per espandere la canzone oltre il canonico minutaggio da sala di registrazione. Pur nella maestria del sestetto sul palco però (con basso e batteria di Stephen Campbell e Jack Ryan, fiati di Dean Mitchell e Justin Johnson, organo di Deshawn Alexander) l’impressione alla Santeria è stata diversa, a farci preferire musicalmente parlando, il risultato discografico della produzione della MK Band, rispetto all’esecuzione dal vivo. Poi, non v’è paragone tra l’assistere a un concerto (e la presenza scenica del faccione di King con gli altri centrava in pieno il bersaglio) e ascoltarne lontanamente un album (ultimo suo, a proposito, Carolina Confession). Ma è di esiti musicali che stiamo parlando e qui, la tendenza a prendere percorsi inusuali rispetto alle tracce abituali ha dato talora l’impressione di non aver la completa padronanza di riportare tutto a casa, se non restringendo sul proprio strumento quanto gli altri tendevano ad allargare. Perdonandogli allora la giovane età e uno sperimentalismo insito al genere, ci accorgiamo che quanto cercassimo in King non è stata forse l’abilità strumentale che ritroviamo anche nella stessa band, ma interazione e maestria a dirigere l’orchestra che i maestri (appunto..) non perdono mai di mano, quantunque impegnati a fare la loro parte nell’economia della baracca. E per alloggio di tal fatta s’intende non solo l’esiguo minivan di una rock’n’roll band in tour, ma il carrozzone circense a cui dagli Allman in poi ci hanno abituato le comunità musicali del Sud, dove era cresciuto un bimbo come Derek Trucks, per esempio.
Quello che notiamo del King in questione invece è che, anche ispirandosi a quel mondo, non sia riuscito a trasmetterne qui l’idea di esserci dentro, tradendo dal vivo una lezione ben interpretata ma non ancora fatta propria. A sfalsarne gli intrecci inoltre, dei pessimi suoni che hanno confuso le trame sonore senza mai assestarsi definitivamente, già quando un “wall – of – sound” da gran gruppo soul pare accoglierlo sul palco. Sarà su Where I’m Headed l’apertura delle danze, brano leggero e quasi cantautorale dall’ultimo lavoro e destinato ai solismi finali, come in tutte le scelte esecutive della serata. Ma se Booty Stank e Ain’t Nothing Wrong With That sono quelle che ci immettono più di altre in ambiti da southern – rock psichedelico, qualcosa mescola fin troppo dissonanze free jazz e improvvisazione funk in Fraudolent Waffle, talora a confonderne i percorsi. Molta carne al fuoco, si direbbe, anche se la voce del paffuto front – man sovrasta l’insieme, pastosa come quanto di meglio possa addirsi al genere, quand’anche intento ad assolo sopra le righe e non sempre nell’accezione positiva del termine. Perché se in un funkeggiare dei brani come Rita Is Gone avrebbe calzato a pennello persino un vocione confidenziale alla Barry White, l’impulsività chitarristica del nostro sposta l’attenzione a un fraseggiare grondante tecnicismi non sempre sì blues alla sei corde, impeto giovanile ad aggiungere anziché togliere, com’è più opportunamente consono per certo sound a palesarne lo spirito. Centralità della serata allora più spostata a pezzi dalle ultime Confessions, com’è naturale in un tour per l’uscita del disco, il ragazzo che sembra divertirsi e il pubblico apprezzare: spiccano così songs come la solare Autums Rains, cedendo poi il passo alla dolcissima Goodbye Carolina prima delle vecchie quanto più aggressive Good Man o, finale, Plant Your Corn Early. Prima dei bis però, salutandoci a neanche due ore di uno spettacolo apparso un po’ meno corale e più chitarristico, molto improntato a mescolanze strumentali forse non sempre coerenti, una quindicina di canzoni e tanti saluti con Remember e Confessions, di nuovo dall’ultimo album, proprio di questi giorni.
Matteo Fratti

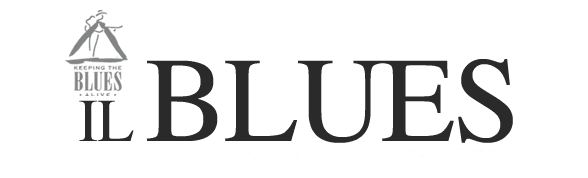








Comments are closed