Parchman Prison
Hope in hopeless world – Some Mississippi Sunday Morning
di Sara Bao e Matteo Bossi
Ci sono luoghi, carichi di storia e sofferenza o forse proprio per questo, che continuano ad esercitare un richiamo sotto molti aspetti. Come se in qualche modo l’arte non possa sottrarsi dall’affrontare questo carico aggrovigliato di dolore, miseria e umanità. Uno di questi posti è senza dubbio il penitenziario di Stato del Mississippi, meglio noto come Parchman Farm, situato nella contea di Sunflower. Enorme, si estende infatti su una superficie di oltre settanta km quadrati, costruito sul modello delle piantagioni e con, potremmo dire, fini di lucro. Tanto è vero che per decenni l’attività agricola, in primis la raccolta del cotone, produceva utili non secondari per il sistema.
Non molto diversa da altre strutture sorte nel periodo successivo alla guerra civile, con l’aumento della popolazione carceraria dovuto, soprattutto, all’arresto per reati minori (vagabondaggio per esempio) di moltissimi afroamericani, che in questo modo diventavano, di nuovo, forza lavoro a buon mercato. In barba al XIII emendamento della costituzione, approvato nel 1865, che aboliva la schiavitù completando in un certo senso il proclama di emancipazione di due anni prima. È significativo ricordare però, come lo Stato del Mississippi abbia ratificato l’emendamento solamente nel 1995(!) e la certificazione non sia stata inviata ai registri federali fino al 7 febbraio 2013 (!). Potrebbe sembrare paradossale, o forse no, pensando con attenzione alla storia di questa parte di America.
Parchman Farm è il più antico penitenziario del Mississippi e registra uno dei più alti tassi di mortalità dei prigionieri della nazione, oltre a sperimentare continue rivolte. Proprio riguardo ciò, il musicista John Mohead lo scorso agosto mentre ci portava a spasso per le cittadine del Mississippi, passando davanti a Parchman ci ha detto che non poteva accostare per permetterci di scattare una foto altrimenti le guardie avrebbero potuto pensare che fosse un’auto giunta lì per dare un passaggio a qualche detenuto in fuga. Rabbrividimmo e filammo dritti, imprimendo uno scatto mentale a quella cancellata, convinti che fosse più che sufficiente a ricordarci tutto il dolore che racchiudeva.
Questo centro di detenzione è composto da “fattorie” e ospita anche il temuto “braccio della morte”, sia per gli uomini che per le donne del Mississippi. Hanno persino un loro cimitero. Numerosi sono stati anche gli scandali che negli ultimi anni hanno riportato sotto i riflettori il nome di Parchman Farm: talmente tanti e brutali sono stati gli omicidi e le morti che persino Jay-Z ha intentato una class action per conto dei prigionieri per denunciare le condizioni barbare in cui sono costretti a vivere.
Anche in ambito letterario Parchman ha spesso trovato posto, che sia per l’ambientazione di un legal thriller di John Grisham (“L’appello”), una citazione marginale o per una presenza più massiccia. È il caso dell’intenso romanzo “Canta, Spirito, Canta” (NN Editore), della scrittrice mississippiana Jesmyn Ward. Un racconto polifonico, struggente, fatto di legami, vuoti e presenze, fantasmi e speranze, acque e alberi, Parchman Farm è un riferimento costante. Sia il nonno (afroamericano) che il padre (bianco) del protagonista, il tredicenne Jojo, ci sono passati, il secondo ne sta per uscire. “Parchman è uno di quei posti che ti fregano perché non ci credi che è una prigione, non sembra così tremendo quando arrivi, non ci sono muri né niente. […] a noi ci chiamavano i banditi, perché lavoravamo sotto i sorveglianti, che erano detenuti pure loro ma erano stati scelti dai capi per controllarci, era erano armati.” Così la descrive a Jojo il nonno Pop, mentre il fantasma del suo amico Richie continuerà a far visita al ragazzino.
Senza trasformare questa introduzione in un excursus sul “prison-industrial complex” di un paese, gli Stati Uniti, che può “vantare” la più numerosa popolazione carceraria al mondo, oltre due milioni di persone. Per quello, volendo, si può visionare il documentario di Ava DuVernay “XIII Emendamento” (2016), regista molto legata a queste tematiche (“Selma”, “When They See Us” o il recente “Origin” da un lavoro di Isabel Wilkerson). C’è però una frase, espressa nel finale del film a fornire uno spunto di riflessione, “L’opposto di criminalizzare è umanizzare e riappropriarsi di questo resta un elemento chiave come comunità, in senso più ampio”.
Tornando alla musica, sin dagli anni Trenta antropologi e studiosi di folklore si sono interessati ai prigionieri di Parchman raccogliendone canti di lavoro, blues o gospel/spiritual, testimonianze di come lo spirito umano sopravviva anche in condizioni estreme. Ritenendo anche, non del tutto a torto, che le condizioni di vita di isolamento del penitenziario lo rendessero una sorta di serbatoi di tradizioni musicali più arcaiche.
Gli appassionati di musica avranno familiarità, probabilmente, le registrazioni effettuate da John Lomax e poi da suo figlio Alan (si veda il CD Jail House Bound per la spedizione del 1933 e il box della Dust-To-Digital intitolato appunto Parchman Farm-Photograph and Field Recordings, per quelle successive), quelle raccolte da Herbert Halpert nel campo femminile (la straordinaria Mattie May Thomas per esempio) o in tempi relativamente più vicini a noi, William Ferris (i gospel cantati da Walter Lee Hood rintracciabili in quella specie di macchina del tempo intitolata Voices Of Mississippi).
Se nelle decadi più recenti non sono state raccolte altre testimonianze da Parchman, ci ha pensato Ian Brennan a riannodare il filo interrotto. Brennan, che i più ricorderanno forsecome produttore di artisti quali Ramblin’ Jack Elliott o Tinariwen (Tassili), si è dedicato negli anni a registrare nei contesti più diversi e lontani da qualsiasi approccio commerciale o esotico. In cerca di bellezza nei posti dove non è scontato trovarla, tra gruppi sociali o etnici marginalizzati o del tutto ignorati. Molto spesso con la collaborazione della compagna, la documentarista/fotografa/scrittrice italo-rwandese Marilena Umuhoza Delli, ha scandagliato vie poco battute in giro per il mondo.
Scorrendo la lunga lista dei suoi progetti ci si accorge di come abbia rivolto la sua attenzione soprattutto all’Africa e all’Asia, passando dal Rwanda alla Cambogia, dal Pakistan alla Tanzania. Citiamone due in particolare che, forse, hanno costituito una sorta di precedente per quello mississippiano. “I Have No Everything Here – Zomba Prison Project” realizzato in un carcere in Malawi o al “Songs of Ghana Witch Camps”, in cui sono raccolti canti di donne accusate di stregoneria e perciò in piccole comunità isolate nel nord de Ghana. Quanto di più distante da un approccio occidentale o canonico alla musica.
Nel febbraio del 2023 si è recato a Parchman, dopo un lento e complesso iter burocratico, per documentare i canti di una domenica mattina, con il consenso del cappellano del carcere. Proprio a causa delle restrizioni su video e foto, l’unico artefatto dell’incontro di Brennan coi detenuti è il suono, fatto che ha reso le voci ancora più impalpabili ed ectoplasmiche. È finito su disco qualcosa di estremamente toccante e profondo, Parchman Prison Prayer. Il produttore ha raccontato che all’inizio i prigionieri erano timidi, ma dopo le prime canzoni hanno preso coraggio e, ispirati uno dall’altro, hanno espresso attraverso la musica i loro sentimenti, le loro speranze e, ovviamente, anche i loro rimpianti e paure.
Registrato tutto dal vivo senza sovraincisioni, “Some Mississippi Sunday Morning” (Glitterbeat) è un viaggio senza filtri, profondamente risonante, disturbante e riflessivo che entra come un sussurro in un mondo musicale che al giorno d’oggi è raramente conscio di queste situazioni. Tutti i profitti derivanti dalla vendita dell’album vanno a beneficio del Mississippi Department of Corrections Chaplain Services.
“Open the Eyes of My Heart, Lord,” un minuto e mezzo di purezza. Così si apre questo disco registrato dentro a Parchman Farm. Il carcerato è L. Stevenson, 29 anni, e chissà quanti ancora dovrà passarne dentro lì. Nella sua voce emerge la rassegnata serenità di chi non può cambiare le cose. Anche con il secondo pezzo, “I Give Myself Away, So You Can Use Me”, restiamo a contatto con una voce giovane, stavolta anonima. È un brano che par buono per qualche colonna sonora da film strappa lacrime, ma sapendo dove è stato registrato e in che condizioni vivono i due che lo cantano e suonano possiamo sentire un brivido forte scorrere sottopelle. Uno scarno andamento circolare, ipnotico e infinito. Non siamo di certo dentro a un film Hollywoodiano costruito a tavolino.
La terza canzone, “Break Every Chain”, è cantata da M. Kyles, prigioniero di 52 anni. “Rompi ogni catena, rompi ogni catena, rompi ogni catena”. Anche qui si percepisce una rassegnata pace interiore. Una scesa a patti con se stessi e con il sistema. Un avvicinamento a Dio, o comunque, a qualcosa che dia un senso alle giornate di un carcerato, una sorta di speranza riposta tutta nella prossima vita. “Jesus, Every Day Your Name is the Same” è un altro brano condensato in un minuto e mezzo, stavolta cantano dal Parchman Prison Choir assieme a C.S. Deloch. Qui, dopo tre brani solisti, emerge la coralità, vera anima del gospel. La sensazione però, pur essendo di fronte ad un coro, continua ad essere quella di una solitudine costante, serpeggia il senso di spaesamento che pare non abbandonare mai del tutto questi prigionieri cantori del proprio tempo in uno spazio ben definito.
“Step into the Water” è definita solo da mani e voce, quella del sessantatreenne N. Peterson che pare già cercare di coinvolgere un po’ di più chi ascolta con un ritmo rotondo, circolare, battesimale, di rinascita. Rinascita che, purtroppo, faticherà a vivere davvero una volta fuori da Parchman. Il successivo è “Solve My Need”, un brano stravolgente. Infernale, profondissimo, inquietante. Una voce che ipnotizza ricordando i canti tibetani, una frase ripetuta in continuazione, echi spaventosi. Un baratro, specchio di tutti i malesseri che Parchman racchiude.
“Falling in Love with Jesus Was the Best Thing I’ve Ever Done” viene cantata da A. Warren, 28 anni, che si accompagna alla voce con una ritmica legnosa e scarna. Un brano a cavallo tra il pop e il rap, sempre in odore di salvezza dell’anima: “la miglior cosa che ho fatto è stata innamorami di Gesù”. Si prosegue con “You Did Not Leave Me, You Bless Me Still” interpretata da J. Sherman, anni 63, voce sabbiosa, animo puro. Di certo non per lo Stato del Mississippi.
Con “If I Couldn’t Say One Word, I’ll Just Wave My Hand” entriamo per la prima volta all’interno di un contesto di band, nuovamente con il Parchman Prison Choir, stavolta assieme al trentaseienne L. Brown. Il gospel che esce da questa sessione non spicca mai del tutto il volo, ha le ali incatenate e poche prospettive di riuscire a rompere le maglie di quelle infide catene. Un brano etereo, tinta cipria, che ti vien voglia di accarezzare e compatire. “I Gotta Run” del giovane L. Stevenson è una canzone che in 50 secondi esprime tutta la versatilità di voci e mani, cose semplicissime ma molto profonde. “Devo correre”. 50 secondi emblematicamente limpidi e con una carica di umanità infinita.
 L’undicesimo pezzo è un “Osanna” cantato da una voce giovane, anche questa ideale da rubarsi per una hollywoodiana colonna sonora da film di redenzione. Peccato che qui la redenzione sia solo una questione personale, ben lontana dall’essere condivisa dal pugno di ferro mississippiano. Anima e corpo che devono scindersi in due vite differenti. Dolore e condanna, purezza e libertà.
L’undicesimo pezzo è un “Osanna” cantato da una voce giovane, anche questa ideale da rubarsi per una hollywoodiana colonna sonora da film di redenzione. Peccato che qui la redenzione sia solo una questione personale, ben lontana dall’essere condivisa dal pugno di ferro mississippiano. Anima e corpo che devono scindersi in due vite differenti. Dolore e condanna, purezza e libertà.
“Locked Down, Mama Prays for Me” è foderata da schiocchi di dita e una voce che intesse un rap freestyle sulla vergogna che prova per aver causato dolore agli altri con le sue azioni. Ricorda i lavori di Gil Scott-Heron. Robinson, 33 anni e A. Warren, 28 anni. Rabbia e rassegnazione che si intrecciano una con l’altra, musica di dio e musica del diavolo che scorrono assieme annodandosi in un brano altamente emblematico.
La terzultima canzone, “It’s in My Heart”, vede nuovamente protagonista il cinquantaduenne M. Kyles con la sua voce pura, calda come il sole del Sud. Dolore e gioia, ancora una volta, si mescolano, cercando disperatamente una via di scissione. Il trentenne D. Thomas con “I’m Still Here” porta il gospel verso la modernità. Voce e schiocco di dita, semplicità estrema che regala eleganza e trasparenza al pezzo. Un titolo, anche questo, decisamente significativo.
Torna, infine, per la terza e ultima volta il Parchman Prison Choir, qui assieme a C.S. Deloch e a M. Palmer per chiudere questo prezioso disco-testimonianza con 7 minuti di pura tradizione: “Lay My Burden Down” è la canzone redentoria per eccellenza. Il canto qui si fa finalmente collettivo, gioioso, liberatorio. Non siamo più all’interno di Parchman Farm, ma in una vera chiesa evangelica. Applausi, cori, improvvisazione melodica e ritmo serrato per stabilire una connessione forte tra l’anima e una nuova vita che l’attende pochi passi più in là. Sparisce finalmente l’individuo rassegnato: c’è il profumo della libertà, della festa e della convivialità di una comunità.
Dal 2010 uno dei marker del Mississippi Blues Trail Marker è stato apposto anche nei pressi di Parchman, rievocando l’importanza musicale di alcuni degli artisti che ci sono stati da Son House e Booker T. Washington “Bukka” White, perfino il padre di Elvis, Vernon Presley fino ad esempio, a Terry Big T Williams o ancora a David Kimbrough Malone figlio del compianto Junior Kimbrough. Difficile dire se in futuro sentiremo ancora parlare di qualcuno di questi detenuti. Di sicuro alcuni degli standard gospel hanno trovato un nuovo abito, molto più scarno, cupo, sornione. Gospel che si sono patinati di false speranze e di illusioni, ma qualcuno anche di redenzione definitiva, di umanità disarmante, di libertà mentale finalmente raggiunta: “Devi uscire di prigione mentre sei ancora in prigione”.
Sara Bao e Matteo Bossi

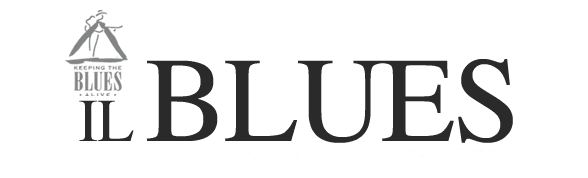









Comments are closed