The Blues Lines
di Matteo Bossi
Ogni artista ha un suo modo di tracciare la sua rotta in ambito musicale. Non vi è dubbio che quella di Chris O’Leary sia stata del tutto singolare. Ex Marine, poi per anni al fianco di Levon Helm nei Barn Burners, poi come ufficiale di polizia federale, prima di dedicarsi ancora esclusivamente alla musica. Ci ha parlato di tutto questo (e altro ancora) nel corso della nostra conversazione, originata dalla pubblicazione del suo nuovo album, “The Hard Line”, il primo su Alligator, di cui è molto soddisfatto. E del tutto a ragione. “Onestamente è un sogno. Sono cresciuto ascoltando Big Walter Horton, James Cotton, Junior Wells, Albert Collins, William Clarke, Son Seals, Hound Dog Taylor… ho tuti questi dischi nella mia collezione. Sognavo da decenni di essere con Alligator”.
Hai citato tra i tuoi idoli James Cotton e raccontato come uno dei primi dischi di blues che hai ascoltato sia stato “Hard Again” di Muddy. Poi vent’anni dopo o qualcosa del genere, sei diventato amico di Cotton come è successo?
È stato quando suonavo con Levon, perché lui e Cotton erano vecchi amici. Suonavamo in questo club a New Orleans e un giorno ero in un negozio di cappelli nel French Quarter e il mio bassista mi da un colpetto sulla spalla. C’era lì Cotton! Straordinario, doveva suonare con noi quella sera. Ero nervoso ma andai da lui e non avrebbe potuto essere più gentile. Abbiamo fatto amicizia ed è stato molto buono con me. Sai talvolta quando incontri i tuoi eroi hai aspettative talmente alte che rischi di rimanere deluso…con James non è stato così. Era il massimo e oltre, una persona splendida. Il mondo è un posto peggiore senza di lui.
Quello doveva essere il “Funky Little Club On Decatur”, di cui canti in una canzone del nuovo album.
Esatto.
Uno dei primi concerti che andasti a vedere fu The Band negli anni Ottanta, quando tornarono insieme?
Esatto. Earl Cate suonava la chitarra con loro, Richard (Manuel) era ancora vivo e c’era Levon con Rick e Garth. Con mio padre e mio zio Mike andammo ad Albany, la capitale dello stato di New York a vederli. E circa quindici anni dopo ero in una band con Levon. La vita è buffa talvolta. Ho sempre suonato musica, fin dagli anni del liceo, chitarra e armonica dopo che mio padre me ne diede una. Ero appassionato perché a casa mia si ascoltava sempre. La domenica a casa poteva esserci pola, opera, Bruce Springsteen, Muddy Waters…Poi finito il liceo mi suono unito ai Marines. Quando ne sono uscito sono andato al college, al Marist, nell’Upstate New York. E lì c’era una scena blues molto viva; Joe Louis Walker viveva lì, come Pete Kanaras che ha suonato nei Nighthawks, Murali Coryell…era davvero buono per essere in una piccola città. Cominciai ad frequentare meno le lezioni e a passare più tempo a suonare e andare a vedere blues. Poi ho formato una band, suonavamo a livello regionale e qualche tempo dopo ci siamo uniti a Levon.
Come vi siete conosciuti?
Avevamo un amico comune. Il fotografo per The Band era Elliott Landy e quando lui ha smesso è stato George Lembesis a proseguire in quel ruolo. E George era un nostro amico. Stavo realizzando un demo, George ne prese una copia e lo fece ascoltare a Levon, sapendo che amava il Chicago blues. Ecco come è successo. E poi Levon venne a suonare sul demo e si è divertito molto.
Vi chiamavate Eldorado Kings? L’episodio è anche citato in “Levon”, il libro di Sandra B. Tooze.
Si esatto! Suonavamo molto blues, soprattutto Chicago, Muddy, Walter, Junior Wells, Big Walter, Sonny Boy…Avevo un po’ i paraocchi, ascoltavo Little Walter ogni santo giorno. Mi svegliavo, mangiavo qualcosa e mettevo su Little Walter e Sonny Boy…tutti i giorni. Andare a New Orleans con lui mi ha sconvolto del tutto, ha aperto mille possibilità, ancora all’interno della tradizione…già solo la strumentazione, vedevi una band Dixieland dietro l’angolo…vivere a New Orleans è stato un momento importante per la mia crescita come musicista.
Ed è qualcosa che fa ormai parte di te, lo si ascolta anche nell’album.
È il mio luogo preferito, può essere sporca e cattiva ma l’adoro. Il club, l’American Cafe, purtroppo chiuse e Levon mise su un treno me, Pat il chitarrista e Frankie il bassista, e ci disse, “ragazzi vi spedisco su a New York, appena sistemo le cose qui ci ritroveremo a Woodstock e pianificheremo il da farsi”. Così prendemmo il trano da New Orleans fino alla Penn Station di New York. Ti giuro che ci vollero almeno due giorni, un lungo viaggio! Quando tornò ci disse che quella era la band e avremmo cominciato a fare tour. Ed è quel che abbiamo fatto per sei anni.
Non avete registrato nulla con quella line-up dei Barn Burners?
Qualcosa abbiamo registrato, ma non so dove siano finite, in qualche archivio al Barn forse. Su alcune di esse Bob Margolin ha suonato la chitarra e David Maxwell il piano, ma non venne pubblicato nulla. La versione originale di “The Grass Is Always Greener”, che ho inciso sul mio primo album, l’abbiamo fatta con Levon ed è lì negli archivi. Mi ha anche aiutato a scrivere un altro brano, “Waters Risin’”, ha trovato lui il groove.
Sia Cotton che Levon Helm sono cresciuti nei dintorni di West Helena.
Si, nella contea di Phillips. Se guardi dall’argine vedi quasi Robert Junior (Lockwood), Pinetop…tutti quelli che sono cresciuti da quelle parti o di là dal fiume, in Mississippi. Sono tutti là. Abbiamo suonato al King Biscuit lo scorso anno ed è come un homecoming, tutti gli amici di Levon sono venuti a sentirci. Amo quel posto. Se vai al Delta Cultural Museum c’è la batteria originale di Peck Curtis / Sonny Boy ai tempi del King Biscuit, beh è stato Levon a donarla al museo. Peck era uno dei suoi eroi. Levon ad un certo punto ha avuto quella batteria, l’ha tenuta a Woodstock per un po’ e poi l’ha donata. Lì è pieno di storia. Dopo il King Biscuit, la domenica abbiamo suonato a Clarksdale e poi anche al Pinetop’s Homecoming con Bob Margolin, suonando solo cose di Muddy. Ovviamente lui non c’è più ma suonare con Bob è la cosa più vicina.
Poi cosa è successo? Ti sei dovuto fermare ad un certo punto?
Con Levon stavamo facendo un lungo tour ed avevo avuto problemi alla voce. Eravamo nel sud della Florida in un posto di nome Bamboo Room per due serate. Ma non avevo più nulla. In qualche modo sono riuscito a finire le serate e sono andato a New York a farmi vedere da un dottore. Mi ha esaminato con un endoscopio e mi ha detto, “devi smettere di cantare”. Mi hanno proposto opzioni chirurgiche, avevo dei noduli…ma non sembrava una buona idea. Così mi sono fermato per un po’ di tempo e poi la vita ha preso il sopravvento. Mi sono sposato e ho finito per diventare un ufficiale di polizia federale…le mie opzioni erano limitate e non potendo fare musica ho dovuto ricorrere a quel che avevo appreso nei Marines. Sono diventato un poliziotto per un po’. Se sei un musicista e sai che è quella è la tua vera vocazione ma non puoi farlo, beh questo ti lascia un vuoto dentro. Così ho ripreso, ho fatto qualche telefonata, la mia voce era tornata, ho frequentato un vocal coach, prendevo meglio le tonalità…cantavo davvero forte. Gente come Lee Roy Parnell o Kim Wilson mi dicevano, “Chris devi rallentare, altrimenti ti farai male”. Ora canto ancora forte ma non quanto prima. Ho chiamato anche Bob (Margolin ndt) e persone che potevano indirizzarmi nella giusta direzione. Bob mi ha procurato un contratto con la Vizztone. Per sei o sette anni ho continuato a fare entrambe le cose, il poliziotto e il musicista. Riuscivo comunque a tenere circa cento date l’anno. Poi alcuni infortuni avuti quando ero un marine e il fatto che volevo davvero fare solo alla musica, passavo più tempo a cercare di incastrare i vari impegni che a comporre musica, mi hanno spinto a dedicarmi full time alla musica. Ed è stata una gran cosa.
Come hai sviluppato la tua scrittura?
Mio padre è uno storyteller, perciò è qualcosa di ben presente in famiglia. Per Levon la canzone era tutto. Ho imparato molte lezioni da lui, ma la più importante è che qualunque cosa tu stia facendo, cantare, suonare un assolo o una parte ritmica, se non stai sostenendo il racconto della canzone, beh allora dovresti fare altro. Ti dirò una cosa, per questo nuovo album, Bruce Iglauer è stato di grande aiuto. Se ascolto i miei primi dischi, ci sono canzoni di sette o otto minuti…Bruce ha reso la mia scrittura più succinta e centrata. Durante le registrazioni del disco ero in contatto con lui e mi ha reso un autore migliore. Dopo tutti questi anni la sua esperienza è stata preziosa. Anche i brani che non sono finiti sul disco li sto rielaborando e ho già scritto buona parte del prossimo disco. La cosa positiva di aver vissuto una vita folle è che ho un sacco di esperienza cui attingere, buone e meno buone.
In un brano, “I Cry At Night”, fai riferimento ai veterani che tornano dopo aver prestato servizio con sindromi da stress post trauma e altri problemi.
Questo ambito lo avevo tenuto da parte. Mio padre è a sua volta un veterano e quando ha finito il servizio è tornato a scuola ed è diventato uno psicologo, ha preso un dottorato. Quando sono tornato dalla guerra, le cose non andavano bene per me, non mi ritrovavo. Mio padre sapeva cosa stavo passando, non solo in quanto veterano ma anche per il suo lavoro come psicologo. Molti veterani però non dispongono di questo. Ed è qualcosa per me molto importante. Grazie ad Alligator ho una piattaforma più ampia ed è una mia responsabilità porre attenzione su questo, perché è un problema in questo paese. Ancora oggi. E il paese, il governo non può voltare le spalle ai ragazzi che tornano a casa dopo aver prestato servizio.
E c’è Mike Welch alla chitarra nel brano.
Quando l’ho scritta pensavo a una cosa nello stile di Fenton Robinson. E forse di suonare io stesso la chitarra. Ma Bruce mi ha detto, “portiamola in un’altra direzione. Io ci sentirei bene Otis Rush qui”. Ed entrambi abbiamo subito pensato: Mike Welch. Mike ha il suo stile ma penso non ci sia nessuno in grado di evocare lo spirito, la drammaticità, il vibrato di Otis come lui. E che professionista! Gli abbiamo mandato la traccia dicendo che sarebbe stato perfetto per questo pezzo. Gli è piaciuta e giuro che ci ha rimandato l’assolo tempo un giorno ed era perfetto. Bruce ha detto, “facciamo qualche aggiustamento qua e là” e in un quarto d’ora Mike li aveva fatti. Il mio pianista, Brooks Milgate, suona anche con Mike. Sono stato contentissimo di averlo sul disco, è di sicuro uno dei migliori chitarristi in circolazione.
Mi piacciono molto le cose che ha fatto col compianto Mike Ledbetter.
Oh assolutamente. Hai mai visto quel video, credo lo abbia fatto Nick Moss, in cui Mike Ledbetter canta l’Ave Marie in una chiesa da qualche parte? Anche la mia ex moglie soffriva di epilessia e può essere devastante, anche le medicine che prendeva per tenerla sotto controllo erano serie. Che perdita è stata, la scomparsa di Mike, un vero shock.
Sei mai stato derubato come canti in “Who Robs a Musician?”
Mi è successo si! Come ogni band che è spesso in tour, tutti siamo stati derubati. Siamo sempre in giro su un van che in pratica dice “venite a rubare, qui c’è roba di valore”. L’ultima volta ci è successo dopo il King Biscuit, siamo andati di là dal fiume e ci siamo fermati in un Cracker Barrel a West Memphis. Ci era successo anche a Chicago, ma questa volta è stato peggio, era l’ora di pranzo, ci hanno preso un sacco di materiale. Ma appunto è come rubare ai poveri, già non guadagniamo molti soldi. Perciò sì è frutto di esperienza diretta.
Un altro pezzo “Things Ain’t Always What They Seem” mi ricorda certe cose di Delbert McClinton.
Delbert è una grossa influenza per me. La canzone l’ho scritta anni fa, ma nella sua versione iniziale aveva tre personaggi differenti e tre storie parallele e separate sul tema comune “le cose non sempre sono quel che sembrano”. L’ho mandata a Bruce e la sua reazione è stata, “amico, non puoi cavartela così, stai chiedendo a chi ascolta di seguire non una ma ben tre storie in una canzone di cinque minuti”
Come Bob Dylan, per esempio “Tangled Up In Blue”.
Esatto! Infatti Bruca ha aggiunto, “…a meno che il tuo nome non sia Bob Dylan o Leonard Cohen! Uno non dovrebbe aver bisogno di una mappa per decifrare la tua canzone”. E ancora, “perché non scegli un personaggio e sviluppi quello?”. Così ho fatto. In una notte ho riscritto il testo, soffro d’insonnia. E l’ha resa una canzone molto più potente. La cosa singolare di Delbert è che può fare country, blues o soul e viene comunque fuori come Delbert e in qualche modo suona del tutto autentico. Non mi viene in mente nessun altro che possa viaggiare tra i generi suonando come sé stesso. È straordinario. Una volta ho suonato con lui a Nashville, abbiamo fatto un pezzo di Jimmy Reed, è stato fantastico. Mi ha solo detto,”hai un’armonica in La?” E gliene ho data una.
Hai pubblicato un paio di dischi su American Showplace Music, l’etichetta di Ben Elliott, scomparso nel 2020.
Si è stato all’inizio della pandemia. Aveva un cancro ma non ho mai pensato che non ce l’avrebbe fatta. Ben era un combattente. Le cose sembravano andare meglio e poi all’improvviso se ne è andato. Credo che abbiamo lasciato in sospeso molte cose io e lui. Si era parlato di realizzare un album Americana…è stata una grande perdita, non me lo aspettavo. Non Ben, non conosceva il concetto di arrendersi. Qualsiasi cosa lo abbia abbattuto doveva essere forte. Ci siamo conosciuti la prima volta quando ho registrato su un disco di Hubert Sumlin, “About Them Shoes”. Ben era l’ingegnere del suono insieme a Rob Fraboni. Levon mi aveva coinvolto, ma ero l’unico signor nessuno in mezzo a rockstar come Keith Richards, Eric Clapton, Blondie Chaplin…ma è stato divertente. Ho cercato di farmi raccontare de persone come Cotton o Hubert. Mi sono specializzato in storia al college e avere i loro racconti di prima mano…queste persone erano la storia musicale americana in carne e ossa. Alcune storie che Cotton mi raccontava erano difficili da comprendere anche per la sua voce. Hubert me ne ha dette alcune incredibili su Wolf. Cotton mi disse che la scena che si vede nel film Cadillac Records in cui Little Walter sfonda con la macchina una vetrina è successa davvero, lui era là.
Negli ultimi anni Levon ha avuto diversi riconoscimenti, Grammy per “Dirty Farmer” e per i suoi lavori con Larry Campbell.
Era in una buona posizione quando è mancato. Vado ancora al Barn, andiamo lì a pescare in un laghetto con mio figlio e il mio figliastro. Chiamo sua moglie Sandy. Il Ramble è ancora attivo, se ne occupa in pratica sua figlia Amy, che è una grande cantante. Quanto a New York non è mai stata per il blues una città come Memphis o Chicago. Con Levon abbiamo suonato all’inaugurazione del B.B.King ma poi ha chiuso. Lì ti trattavano benissimo, ma d’altra parte con Levon venivamo sempre trattati molto bene. Mi ricordo quando Bobby Keys suonava con noi, è rimasto nella band per circa un anno, lui e Levon giravano nella stessa auto. Non penso che ci sia nessuno come lui nella storia del rock…ha suonato con Beatles, Stones Clapton, Elton John, Joe Cocker, Delenay & Bonnie…era un ragazzino quando il Colonnello Parker lo chiamò per suonare il sax baritono su “Return To Sender” di Elvis. Dovrebbe essere nella Hall Of Fame. Anche Hubert. Tutti i chitarristi inglesi, Page, Beck, Clapton vedono Hubert come una enorme influenza. Forse lo hanno inserito ma era tardi. Che senso ha quando sono morti?
Come vedi la giovane generazione di artisti blues?
Penso sia una buona cosa che artisti giovani vogliano rivendicare la loro eredità culturale. Qualcuno come Kingfish, Marquise Knox o DK Harrell, perché è semplicemente una eredità afroamericana. È qualcosa che amo e che sento vicina, ma posso solo scrivere di quello che conosco…alcuni temi del blues sono universali, indipendentemente dalla tua cultura d’origine, la gioia o il dolore sono universali.
È un aspetto, questo dell’universalità dei temi, di cui ti sei accorto già nel periodo coi marines?
Non proprio, nei marines vedi solo dei frammenti dei luoghi in cui ti trovi. E di solito sono posti al centro di crisi, con persone che ne stanno passando di tutti i colori. Quando ti dicono che vedi il mondo, non è del tutto vero. Anzi mi ha reso un po’ pessimista. Andare in tour con Levon o con la mia band mi restituisce ottimismo, perché nonostante le barriere di linguaggio o cultura, la gente risponde nello stesso alle stesse cose. Allora non lo avevo capito. Anche questo mi piacerebbe venire in Italia, non ci sono mai stato ed è di sicuro nella mia lista ideale. Altri posti in cui mi piacerebbe suonare sono Grecia, Giappone e Australia. Lì ti considerano come una rockstar e il pubblico è molto competente. Qui se suoni in un club c’è il cinquanta per cento di possibilità che la gente non sappia nemmeno chi fosse Hubert, specialmente tra i più giovani.

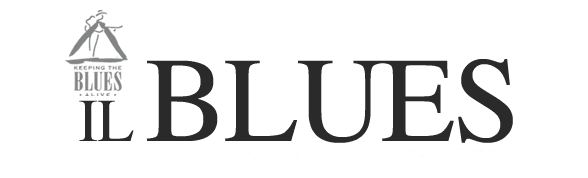









Comments are closed