Dieci Anni Creativi
di Marino Grandi
L’apparizione di “So Many Roads – An Anthology 1964-1974”, cofanetto retrospettivo dal titolo eloquente, aveva coinciso col sorgere di un dubbio, alimentato da alcune similitudini. Innanzitutto, l’arco di tempo coperto che, guarda caso, era lo stesso che due doppi CD (“London Blues” inerente al periodo Decca e “Room To Move” inerente al periodo Polydor), avevano abbracciato allorché erano apparsi sul mercato discografico verso la fine del 1992/inizio 1993. Si dirà: sono trascorsi diciassette anni e quindi un evo letto con l’occhio di oggi e quindi perché non riproporre quel materiale? Ed era proprio questo il ragionamento che stava alla base del nostro dubbio, anche perché era molto più facile rimettere in circolazione il prodotto così come era stato concepito a suo tempo, anziché imbastirne uno nuovo. Meno male che il compilatore, Mark Powell, pur non riuscendo a sfuggire più di tanto alle riproposizioni (circa il 50% ) ha cercato con le 74 tracce presenti, di fornire un’immagine di Mayall che non fosse agiografica oltre ogni limite, come dimostra la presenza di materiale tratto da “Memories”, “Ten Years Are Gone” e “The Latest Edition”, cioè non certo il meglio. Ma c’è un’altra considerazione da fare, vale a dire che attraverso il lavoro di ristampa di tutto il materiale di Mayall dell’era Decca realizzato nel giro di questi ultimi cinque anni e da noi abbastanza puntualmente segnalato in queste pagine, tutto ciò che trovate in “So Many Roads” di quel periodo, aveva già visto la luce in singoli compact.
E siccome di Mayall abbiamo parlato più e più volte, vediamo allora cosa c’è all’interno di “So Many Roads”, aprendo allora questo vaso, non di Pandora, ma di Euterpe (che speriamo non se ne abbia a male se l’abbiamo tirata in ballo) e ci imbattiamo nei primi vagiti indecisi, targati 1964 che, se oggi fanno sorridere, indicano già, sia pure in nuce, l’idea fondamentale che accompagnerà il leader per tutta la carriera: l’ispirazione è oltreoceano, ma la creazione dei brani è quasi esclusivamente opera sua. Proseguendo nel primo CD, ecco che l’incontro con le figure di Eric Clapton e John McVie fanno sì che “Telephone Blues” e “I’m Your Witchdoctor” il suono della band acquisti quel sapore meno scolastico e più vissuto che si addice al blues stesso. Esempi lampanti di questa metamorfosi in corso, che indica come il British Blues stia diventando adulto, stanno racchiusi nella “Have You Ever Loved A Woman” dal vivo e squisitamente odorante di jam e nella “All Your Love” di Otis Rush in cui la chitarra di Clapton si spinge verso la saturazione. L’emigrazione di Clapton verso i futuri Cream, obbliga John a procurarsi un nuovo chitarrista (tale Peter Green), cui addirittura abbina un batterista altrettanto pivello come Aynsley Dunbar. Ma saranno proprio loro, i due neo-Bluesbreakers, a dare concretezza all’ennesima svolta musicale del leader. Infatti, se con “Dust My Blues” la chitarra di Green graffia, nel resto dell’album “A Hard Road” presenti un’aria meno ficcante rispetto ai tempi con Clapton, così come testimoniato dalla sensibile versione di “Double Trouble”(qui rovinata dalla rimasterizzazione operata) o da “The Supernatural”, mentre “It’s Over”, autografa di Mayall, riacquista il carattere portante della scansione ritmica del blues.
Ma siccome siamo già da sette brani nel secondo compact, dobbiamo segnalare che anche se Green e McVie lasciano Mayall per fondare i Fleetwood Mac e Dunbar per veleggiare verso Jeff Beck, John non si lascia scoraggiare. Ingaggiato un nuovo, imberbe, chitarrista, rispondente al nome di Mick Taylor, recuperata la sezione fiati precedentemente accantonata, inserito un batterista pesante come Keef Hartley, Mayall con la pubblicazione del singolo “Suspicions (Part One)” lascia già intuire come il futuro sarà tinto di un blues fuso intimamente con le tematiche sonore del R&B (ecco la necessità di Hartley dietro i tamburi). Dall’LP “Crusade” fa capolino “Oh Pretty Woman”, ma è chiaro che il discorso sia in progress. Peccato che, come d’altra parte nei due doppi CD citati in apertura, anche qui non ci siano tracce prelevate dall’esperimento che John ricava dal suo lungo tour, intrapreso tra l’ottobre e il dicembre 1967, attraverso Gran Bretagna, Irlanda e Olanda e messo su vinile in origine con il titolo “The Diary Of A Band Vol 1 & 2”, setacciando sessanta ore di registrazioni dal vivo realizzate nei club. Spiace, perché se testimonianze relative ad episodi come “My Own Fault” possono assurgere ad esempi di blues elettrico, altre come quella di “Blood On The Night”, possono essere lette come passaggi storici di free, anticipatori del cambiamento che sta per avvenire con “Bare Wires”. Ed è qui che jazz e blues si saldano, come dimostrano i fiati che si sfidano e si inseguono in “Look In The Mirror”, dimostrano di saper tacere e lasciare lo spazio necessario all’armonica del leader di tessere il blues più limpido in “No Reply”, grazie anche ad un parco accompagnamento di chitarra e percussioni. Ma l’inquieto Mayall guarda ormai oltre oceano.
La frattura col passato si realizza con “Blues From Laurel Canyon” (1968), da cui possiamo ascoltare la riflessiva “Medicine Man” e la profetica “Fly Tomorro”, ultime tracce di Mick Taylor prima di approdare alla corte dei Rolling Stones. Trasferitosi negli Stati Uniti, John lavora per mettere a punto un nuovo percorso generale. Il geniale esperimento di un gruppo privo della batteria e in cui la ritmica sia affidata al solo basso lo intriga non poco. Affidato questo ruolo, fondamentale nell’economia del gruppo che deve nascere, a Steven Thompson, raccoglie intorno a sé il chitarrista Jon Mark e il multistrumentista Johnny Almond e testa la band a Londra, al Marquee, nel giugno del 1969. Convinto, vola negli USA dove inizia un tour che ha come punto focale il Fillmore East di New York. La sua esibizione del 12 luglio viene registrata e dà corpo all’album “The Turning Point”, qui rappresentato dallo straordinario tempo medio, fintamente soft, “California” e da quella “Room To Move”, che diventerà uno dei marchi distintivi dell’armonicista Mayall; il tutto inserito in un’atmosfera jazz e blues dove l’improvvisazione ritorna padrona ma senza mai strafare. La fase acustica del leader, visto il successo ottenuto, prosegue con “Empty Rooms”, ma qui le sonorità si fanno molli e il compiacimento verso la musica americana sopisce le idee. Mayall se ne accorge e cambia formazione. Sette mesi dopo la pubblicazione di “Empty Rooms” vede la luce “USA Union”, simbolica fusione tra lui, Larry Taylor, Harvey Mandel (ex Canned Heat) e il violinista Don “Sugarcane” Harris, qui rappresentato fondamentalmente da “Crying”, in cui Harris costruisce lancinanti sonorità, anche se traspare la mancanza della batteria. Soffrì invece di autocelebrazione “Back To The Roots”, rimpatriata realizzata da Mayall, in cui è affiancato da molti partner che hanno suonato con lui nel corso degli anni. Meno male che la scelta dei brani è stata limitata, ma nonostante ciò, spicca più che altro il lavoro di Mandel in “Unanswered Question” e quello di Johnny Almond in “Television Eye”.
Il quarto CD si regge sugli episodi tratti da “Jazz Blues Fusion”, frutto di registrazioni dal vivo effettuata a Boston e New York nel novembre e dicembre 1971. Questo lavoro, come recita il titolo, è il ritorno a quelle fusioni musicali che John aveva già iniziato anni prima, con la variante, niente affatto trascurabile, che la band era all american blacks, solo lui e Larry Taylor erano dei visi pallidi. E poi suonare con artisti come Freddy Robinson alla chitarra, Blue Mitchell alla tromba, Clifford Solomon al sax e Ron Selico alla batteria, non può far altro che farti sentire a casa. Prendevano forma così, con semplicità, pagine stupende come lo scandito “Mess Around”, in cui i fiati mostrano come si entra e si esce da un pezzo, lo stravolgente e polveroso slow “Country Road”, dove ognuno dà il meglio di sé. Il successo di quest’album indurrà John a ripetere l’esperimento, ma “Moving On” appare una forzatura, perché l’appesantimento dell’organico fa perdere le sfumature. Abbiamo sorvolato sia su “Memories”, uscito prima di “Jazz Blues Fusion”, che su “Ten Years Are Gone” e “The Latest Edition”, posteriori a “Moving On”, in quanto era impossibile o quasi trovare brani degni di nota.
Nonostante ciò, questo cofantetto è il ritratto verosimile di un artista che, in dieci anni, ha esplorato la musica Blues in questi tutti i suoi aspetti. Forse iperproduttivo, 19 album a suo nome e due in veste di produttore, ovvero quelli di Shakey Jake Harris e le ultime incisioni di JB Lenoir integrate dalle parole della moglie (peccato, al proposito, che nemmeno uno dei due brani dedicati da Mayall a questo suo mentore, “The Death Of J.B. Lenoir” e “I’m Gonna Fight For You J.B.” sia stato qui incluso), eppure sempre teso a cercare nuovi angoli visuali. Non riuscendoci sempre e scivolando anzi, qua e là, nel “tirare a campare” quando l’ispirazione veniva a mancare. Ma allora a chi è dedicato “So Many Roads”? Sicuramente ai neofiti in toto o a chi di Mayall possiede magari unicamente le ultime opere e solo ascoltandolo si può rendere conto di cosa stia perdendo restando all’oscuro sull’evoluzione musicale scatenata da John in quei dieci prodigiosi e irripetibili anni.
(Il Blues n. 112)

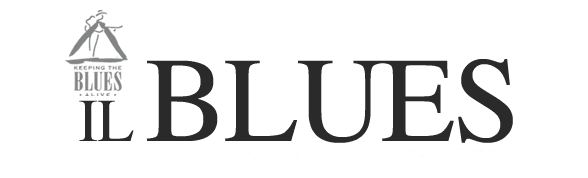

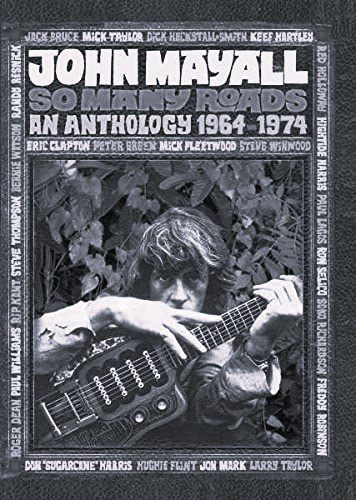







Comments are closed