Lo abbiamo seguito fin dal suo sorprendente esordio, “Age Don’t Mean A Thing” (2016), Robert Finley, dedicandogli anche la copertina del n. 144, contenente una intervista realizzata durante quel che resta, ad oggi, il suo unico passaggio italiano, nell’estate del 2018 al festival Dal Mississippi Al Po. Qualche mese fa è uscito il suo quarto album, “Black Bayou”, nuova collaborazione con Dan Auerbach che lo ha prodotto e registrato per la sua etichetta Easy Eye Sound.
Un bel disco, probabilmente tra i migliori dell’anno che volge al termine, pregno, forse ancor più di altri, della personalità e delle storie di questo quasi settantenne proveniente dalla parte nord della Louisiana. Forse anche perché, come ha raccontato lui stesso, le canzoni non sono state composte prima da altri (vedasi “Going Platinum”) o in parte con la sua collaborazione, come accaduto per “Sharecropper’s Son”, già più centrato sulla sua esperienza. Questa volta molte canzoni hanno preso vita direttamente in studio, con le parole di Finley quasi improvvisate a partire da un tema e il contributo rilevante dei musicisti. Tanto è vero che sono accreditate collettivamente, oltre ovviamente a Finley stesso, anche a Dan Auerbach, il batterista Jeffrey Clemens (in quattro pezzi sostituito dall’altro Black Key, Patrick Carney) e a due nostre vecchie conoscenze, vale a dire, Kenny Brown ed Eric Deaton.
In alcuni brani intervengono anche, con misura, un armonicista, Tim Quine, un tastierista, Ray Jacildo, il percussionista Sam Bacco e due coriste, Christy Johnson e LaQuindrelyn McMahon, rispettivamente figlia e nipote dello stesso Finley. Il suono che si viene a creare è improntato ad una spontanea ruvidezza, su cui la vocalità del leader può incastonare le sue storie, grazie ad una voce possente ed espressiva, usando occasionalmente anche il suo tipico falsetto. La combinazione funziona fin dall’iniziale “Livin Out A Suitcase”, sulle sue esperienze in tour in giro per il mondo, con le incisive svisate della chitarra di Kenny Brown.
In un album intitolato “Black Bayou”, nome di un fiume che scorre tra Texas e Louisiana, non ci si sorprenderà di trovare diversi riferimenti allo swamp blues classico, sia nell’andamento di un pezzo come “Sneakin’ Around”, un aggiornamento di certe pagine storiche su Excello o nella ironicamente lasciva “Miss Kitty”. Convince anche nel midtempo “Gospel Blues”, oscillante, come nella miglior tradizione, tra sacro e profano, combattuto tra l’anelito verso il paradiso malgrado qualche passione, per così dire, più terrena. Ma la sensibilità di Finley si esprime anche in altre direzioni, pensiamo a “Nobody Wants To Be Lonely” è una soul ballad su un argomento insolito, gli anziani lasciati a sé stessi nelle case di riposo,“so many people are left alone, don’t even get a call on the telephone”, canta con voce piena di empatia, forse anche per gli amici che vivono in simili condizioni. Ottimo anche l’altro lento, “Lucky Day”, anche in questo caso centrato l’apporto delle coriste.
Impossibile, infine,non scorgere in filigrana la sagoma di un altro nativo della Louisiana, Tony Joe White nello scorrere di “Alligator Bait”, una “swamp story” dal groove cadenzato, racconto di come il nonno lo abbia usato come “esca per alligatori” nel bayou e abbia fatto lo stesso col padre ai suoi tempi. Con White sembra talvolta condividere anche un immaginario reale e per così dire, ambientale, un aspetto che non sarà sfuggito, crediamo, nemmeno ad Auerbach, che tra l’altro ha pubblicato su Easy Eye l’album postumo di TJW, “Smoke From The Chimney”. Complimenti dunque a Finley e soci per questo “Black Bayou”, davvero un ottimo lavoro, con l’augurio di rivederlo, prima o poi, dal vivo da queste parti.
Matteo Bossi

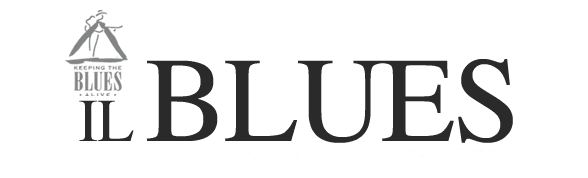







Comments are closed