Soltanto alla fine della nostra conversazione con Coco Montoya ci torna in mente un particolare. L’artista californiano è infatti già collegato alcuni minuti prima dell’orario concordato, come a voler far propria la regola del suo vecchio capitano, John Mayall, sull’essere cinque minuti in anticipo, per essere davvero in orario. Questo modo di porsi da appassionato e studente, è per certi versi rivelatore. Indica innanzitutto il rispetto e l’attenzione di chi cerca di apprendere dalle diverse situazioni in cui si è trovato nel corso di una carriera lunga, eppure non lineare. Pochi sono infatti i musicisti ad essere passati da uno strumento (batteria) ad un altro (chitarra) e dal ruolo di sideman a quello di band leader, affermandosi appieno negli scorsi trent’anni. Il nuovo album su Alligator, “Writing On The Wall“, lo trova in piena forma, circondato, soprattutto, dal suo fidato gruppo abituale.
L’intervista a Coco Montoya
Come è venuto fuori l’album? Ci sembra davvero tra i tuoi lavori migliori.
Si deve all’alchimia che si è creata con tutti, i produttori e tutti musicisti che hanno suonato nel disco, la mia road band, una cosa che non avevo fatto da un po’ di tempo. Volevo assicurarmi che fossimo tutti coinvolti nel progetto su livelli differenti. Ed è stata una magia per noi, sono davvero orgoglioso di questo e molto contento dei risultati.
Avevi già lavorato con Tony Braunagel, ma, credo anche Jeff Paris abbia rivestito un ruolo chiave.
Assolutamente. Tutti i ragazzi sono stati straordinari su questo progetto. Hanno portato i loro talenti e la loro dedizione. Jeff è stato molto importante, è diventato un co-autore ed è stato di grande aiuto in tante altre cose, ha fatto molto più del necessario, una straordinaria aggiunta e una persona che mi ha ispirato a migliorare. Oltre ad essere uno dei musicisti più talentuosi che conosca, dal punto di vista musicale, è tastierista fenomenale, per questo l’ho ingaggiato, ma è un fenomeno anche con chitarra, armonica e canta benissimo…sono grato di averlo nella band.
Come hai selezionato le canzoni? Alcune cover sono piuttosto insolite, attingi da Andy Fraser, Bobby Bland e persino da Lonnie Mack.
“Be Good To Yourself”, la canzone di Fraser, l’ho scelta perché sono un grande fan di Frankie Miller, l’ho scoperta dalla sua versione. L’ho fatta ascoltare a Jeff e lui ha subito detto, “Oh, dobbiamo proprio provare a farla”. Ne ero davvero contento. Ho suonato un paio di canzoni di Frankie Miller in passato, ma questa era una grande occasione per lavorare ad una nostra versione. Tony oltretutto ha bel rapporto con Miller, sono amici. La canzone di Bobby Bland viene da Bruce Iglauer, me l’ha mandata lui. Abbiamo pensato da subito che ci serviva qualcosa che fosse di richiamo verso il blues, un blues, dalle fondamenta, e il groove su questo pezzo è stato molto divertente da suonare.
Bruce mi tampinava da anni per incidere quel brano di Lonnie Mack. Ed è una canzone che amo, guardavo sempre suonare Lonnie, ma ho sempre avuto un certo timore nel provare a farla, almeno finora. Non pensavo di riuscire a tirar fuori un cantato così sincero e sentito come Lonnie, lui ti spezzava il cuore quando lo ascoltavi cantare questa canzone. Tony e Jeff mi hanno dato un’idea su come approcciarla e cercare di farla mia. I ragazzi non hanno avuto paura di trovarmi una voce su canzoni in cui di norma avrei avuto la tendenza ad emulare il cantante originale, come Bobby o Mack appunto. Ma non sarebbe stato il modo giusto di farlo. Non voglio mai scordare la prima regola del blues: l’interpretazione. Fallo a modo tuo. Albert Collins me lo diceva sempre, “fallo a modo tuo, non farlo come lo faccio io. Sarà più interessante, piaccia o meno, se non stai cercando di imitare me”.
Un paio di canzoni mi hanno ricordato un poco i Little Feat. Per esempio “Writing On The Wall”. So che eri amico di Paul Barrere e Richie Hayward. Paul ha anche prodotto un tuo disco, “Dirty Deal”.
Non c’è modo di non rimanere influenzati da Paul Barrere, Richie Hayward e il resto dei Little Feat! Non puoi conoscerli e non ricavarne qualcosa. Sono una grossa influenza sulla mia carriera e sulle mie amicizie, eravamo molto legati, mi manca molto Paul e anche Richie. I Little Feat sono ancora una grande band, mi piace ancora andare a sentirli, vedo Fred Tackett di tanto in tanto. Incidere “Dirty Deal” è stato molto divertente. Le cose che ha tirato fuori Paul…abbiamo messo insieme le canzoni e ottenuto l’OK da Bruce Iglauer, un processo che talvolta può diventare complicato. Ma ce l’abbiamo fatta e le versioni che ne abbiamo cavato erano meravigliose. Aveva un’atmosfera diversa, più ruvida delle cose che avevo fatto in precedenza.
Dopo quello hai realizzato un album prodotto da Keb’ Mo’, a sua volta un lavoro differente.
Assolutamente. E mi piace “I Want It All Back” semplicemente perché Kevin ha detto, “ti produco il disco e voglio prendermi dei rischi, ti daremo un bel calcio nel didietro. Probabilmente a qualcuno non piacerà molto, ma penso sia un bene per la tua carriera. Conosco questo altro lato di te”. Il blues è sempre stato alla base di tutto per me, ma sono cresciuto con molte altre influenze. Mi piacciono molto alcune cose Doo-wop e Kevin ha guardato in quella direzione da subito. Mi ha detto, “se c’è qualsiasi vecchia canzone che ami e potremmo tentare di rifare…” E abbiamo lavorato su molte canzoni, alcune non sono nemmeno finite sul disco, ma appunto ci siamo presi dei rischi. Ed è stato forte. C’è un sacco di grande musica che mi piacerebbe esplorare.
A novembre saranno trent’anni dalla scomparsa di Albert Collins. E John Mayall compirà novant’anni. Trent’anni fa hai lasciato la sua band e cominciato la tua carriera solista. Se ripensi a quel periodo che sensazioni ti restano oggi? Di sicuro è stato un momento cruciale per te.
Un periodo molto burrascoso, dal punto di vista emotivo, per molte ragioni. Albert era malato di cancro e cercavo di essere presente per lui e allo stesso tempo il mio tempo con John Mayall stava per finire. Avevo fatto tutto quello che era possibile nella band ed era il momento di cambiare, ma non sapevo ancora cosa avrei fatto dopo. Inoltre, mi ero ripulito a fine 1992, è successo tutto nello stesso tempo, anche la mia sobrietà. Quando ho lasciato Mayall non avevo un piano, nessuna idea, non ero nemmeno sicuro di continuare a fare musica. Forse sarei ritornato a fare il barista da qualche parte a L.A.? Fu un momento brutto. Albert mi disse che avrei dovuto proseguire da solo, prima di morire mi disse, “devi andare là fuori, ragazzo, devi farlo, non puoi gettare via così tutto il lavoro che hai fatto con John”.
Qual è stato l’aspetto più difficile nell’essere il frontman della tua band?
Io lo chiamavo aprire il mio negozio! Ed è straordinario come puoi passare dall’essere un sideman al lato opposto, cominciare tu stesso a guidare il bus. E dipende tutto da te. Un’altra cosa per la quale mi ha aiutato l’essere sobrio, sapevo che non sarei stato in grado di farlo se fossi stato ancora sotto gli effetti di alcol e droghe; è una responsabilità troppo grande. Fu un grande adattamento. La cosa sorprendente è che via via che ti trovi in determinate situazioni, quando ti metti in proprio, ti vengono in mente cose accadute ad Albert e John…e la tua memoria comincia ad inserirsi, quando c’è un problema col promoter o con l’hotel…potevo vedere tutte queste scene di cui ero stato testimone accanto a loro e capire come affrontavano quelle circostanze. Tutto questo mi è ritornato e ho trovato una forza in me che non sapevo di avere.
Poi hai registrato “Got A Mind To Travel”.
Sì e il disco è finito in mano alla Zomba Music in Europa e stava andando bene, ma alla sezione di New York non volevano saperne. Così siamo andati da Bruce Iglauer per primo e (sorry Bruce!) lui lo ha rifiutato. Andava bene lo stesso, ma siamo andati da lui perché lo rispettavamo molto per la sua storia con Albert o Lonnie Brooks, un altro dei miei eroi…La mossa successiva è stata di chiedere alla Blind Pig e loro lo hanno preso. È stato un processo di apprendimento, ma ripensandoci ora, sono stato davvero fortunato. Non è stato troppo doloroso.
In ogni caso in seguito Bruce ti ha messo sotto contratto due volte.
Io e Bruce abbiamo un buonissimo rapporto. Abbiamo riso, pianto, ci siamo abbracciati e siamo stati arrabbiati l’un con l’altro, siamo stati in disaccordo alcune volte…ma abbiamo anche realizzato ottima musica. Di tutto il materiale che ho registrato con Alligator sono davvero orgoglioso. E quando Bruce è al tuo fianco lo è davvero al 100% e hai alle spalle tutto il team Alligator. Per questo torniamo sempre! (ride) Non c’è un altro gruppo di persone simile.
A volte hai dichiarato che, quando hai iniziato a suonare la batteria con Albert Collins, non eri esattamente un batterista blues.
È più o meno così. Sapevo suonare uno shuffle e capivo, per certi versi, uno slow blues, ma avevo molto da imparare. Non ero davvero preparato per Albert. Lui aveva un bisogno disperato di un batterista, il suo se ne era andato all’improvviso. Parliamo di una situazione in cui lui mi chiamò a casa dicendo, “hey abbiamo dei concerti, puoi farcela?”. Ero spaventato a morte, stiamo parlando di Albert Collins! Ma gli dissi, “certo, lo farò”. Pensavo che avremmo avuto tempo per un paio di prove, così avrei familiarizzato col materiale…ma lui disse, “vengo a prenderti tra un paio d’ore, andiamo a Eugene, Oregon”. Fu il mio primo concerto.
Nel tragitto dalla California all’Oregon i ragazzi della band mi dicevano, “qui c’è uno stop, qui devi rallentare il ritmo…”, mi spiegavano tutti gli arrangiamenti. Nessuna prova. Mi sentivo male, ma ho pensato che ce la siamo cavata bene, è stato molto divertente. Dissi ad Albert, “so che eri in una situazione disperata, se trovi qualcuno che conosce davvero la tua musica, me ne torno a casa. Voglio solo essere sicuro che sia tutto a posto. Ma adoro la tua musica e vorrei imparare di più”. Lui rispose, “resta con me e ti insegnerò io”. E lo ha fatto.
Com’è stato essere in tour con lui nei primi anni Settanta?
Tutto quello di cui avevo bisogno. Non ho mai preso lezioni, non ho una educazione formale. Ho imparato ad orecchio, il che ha lasciato qualche lacuna nelle mie capacità tecniche…non so leggere, teoria, nulla del genere. Non ho studiato lo strumento in questo modo. E per Albert era lo stesso. Semplicemente suonava come suonava. Non analizzava mai troppo. Non ho mai sentito da lui la parola “scala pentatonica” in vita sua. Non gli interessava. Il che era perfetto per me. Ho imparato osservandolo, sentendo le emozioni e il suo modo di fare. Era il mio modo di imparare, apri le orecchie ed il cuore. Certo devi esercitarti e altre cose del genere, e lo facevo. Ma non avevo la formazione di altri ragazzi, vorrei averla avuta, mi sarebbe stato d’aiuto, forse sarei ancora un batterista! Ma ho iniziato a migliorare solo stando attorno ad Albert. Durante il soundcheck mi faceva vedere qualcosa, eravamo solo io e lui, lui si metteva a suonare un groove e mi diceva, “vienimi dietro, ma non pensarci, sentilo. Ci stai pensando troppo”. Ecco come ho fatto. Non sono mai stato un batterista come David Garibaldi dei Tower of Power! Lui ha ucciso la mia carriera di batterista.
In quel periodo Albert non stava registrando. Era senza contratto finchè non firmò con Alligator, tempo dopo.
Verissimo. Aveva fatto un album su etichetta Tumbleweed, come si chiamava?
”There’s Gotta Be A Change”?
Sì. E mi piace molto quell’album. Jesse Ed Davis ci suona e credo Bill Szymczyk era il produttore. Ma erano tempi duri. Ero un ragazzinon e non mi importava molto. Facevano 45/50 dollari a sera suonando in giro. Se ne tiravi su 75 ti sentivi ricco! Mi divertivo un mondo, stavo suonando la musica originale di quest’uomo e mi gustavo tutto, cercando di assorbire il più possibile. Un gran periodo per apprendere qualcosa solo guardando la magia e la forza che Albert possedeva. Ne ero persino confuso. Come fa? Come riesce a guidare per tutte quelle miglia e salire sul palco con mezza band? Voglio dire, a volte capitava ci fosse un nuovo tastierista che non conosceva nulla del suo materiale…Albert ci trascinava in ogni concerto e otteneva sempre un bis. Per dire quanto fosse potente. Ci portava sulle sue spalle. Come riesci a perseverare a tal punto? C’era molto da imparare da lui. Era come un padre, ero giovane e stupido e lui mi teneva davvero d’occhio.
Hai avuto occasione di conoscere e fare amicizia con altri artisti della scena blues West Coast dell’epoca? Gente come Pee Wee Crayton o Shakey Jake…
…e Big Joe Turner o Smokey Wilson. Li ho conosciuti tutti tramite Albert. Ho suonato un paio di concerti con Smokey e accompagnavo Big Joe talvolta. Io e i miei amici, come Walter Trout, venivamo chiamati per questi concerti, “Hey, Big Joe ha bisogno di un batterista chi è disponibile?”
Doug Macleod?
Oh Doug è uno dei miei migliori amici, ci conosciamo da tantissimo tempo. Lo chiamiamo Dubb!
George “Harmonica” Smith lo chiamava così.
Esatto! Per questo lo chiamavamo tutti così. Doug è una delle persone migliori del mondo. Io e lui ne abbiamo passate tante insieme per quanto riguarda l’apprendistato in questo settore. Ed è stato un onore scrivere canzoni con lui. C’era una gran quantità di musica straordinaria a L.A. in quei giorni. Potevi imbatterti in musicisti come Hollywood Fats o William Clarke…a volte davo un passaggio fino a scuola a James Armstrong, era solo un ragazzino ed era amico del mio fratellastro.
Immagino anche Robert Cray, Curtis Salgado e Richard Cousins.
Oh, sì, loro erano i ragazzi del nordovest! Li ho conosciuti quando suonavo con Albert e siamo ancora amici al giorno d’oggi. Ne abbiamo parlato spesso con Robert di come da ragazzi non ci importasse molto dei soldi, tutto quel che volevamo era gravitare attorno a questi artisti. Solo la loro presenza, l’atmosfera…E poi potevamo incontrare molta altra gente grazie a questo, come B.B.King o Lowell Fulson. Ho anche suonato diverse volte con Lowell.
Ad un certo punto hai lasciato il mondo della musica e ci sei tornato solo tempo dopo con John Mayall.
Sì, beh come dicevo, non ero molto interessato ai soldi, ma avevo dei conti da pagare, per la macchina ad esempio, e avevano cominciato ad accumularsi. Lavoravamo ma non sempre con regolarità. Alla fine, ho dovuto occuparmi della cosa e accettare un lavoro. Ho iniziato a lavorare come barista, pensavo di essere ormai uscito dal music business. Come batterista era finita per me, ero arrivato al massimo. Suonavo la chitarra durante i weekend alle jam session, senza alcuna responsabilità. Era liberatorio. Ed è stato lì che mi ha ascoltato John Mayall, a Hollywood.
Avevo una chitarra e un ampli e frequentavo diversi locali per le jam. Un giorno, all’improvviso, mentre lavoravo in questo pub a Laurel Canyon, John chiamò il locale ma io riattaccai subito! C’erano diversi inglesi che venivano al pub e così pensai, “si, come no, sei davvero John Mayall, certo”. Ma lui richiamò e disse, “no, sono davvero John Mayall, sto riformando i Bluesbreakers ma Mick Taylor se ne è appena andato con Bob Dylan, saresti interessato ad un’audizione con la band?” Aveva avuto un nastro della jam a Hollywood. Ecco come è accaduto.
I Bluesbreakers erano i miei Beatles…tutti quei musicisti, una storia incredibile. Ma non l’ho realizzato finchè non ho detto di sì e ci siamo trovati per provare. Ho iniziato a pensare, “Oddio in cosa mi sono ficcato? Come farai a fare qualcosa che sia grande quanto quello che ha fatto Clapton in questa band?”. E John mi ha preso da parte e mi ha detto, “Smetti di cercare di essere qualcun altro, sii te stesso”. Come ti ho detto in precedenza, la prima regola del blues è l’interpretazione. E ha aggiunto, “Eric non è qui, devi suonare queste canzoni come se fossero tue”. Mi ha, per così dire, liberato. Aveva molto senso. Non devo essere Eric Clapton o Mick Taylor. Sono i miei eroi e musicisti incredibili. Ma era tempo di fare le cose a modo mio, anche in canzoni come “Have You Heard”.
Sei rimasto circa dieci anni? John ha avuto anche un ritorno a livello discografico, con ottimi dischi, “A Sense Of Place” ad esempio.
Sì circa dieci anni. Mi ricordo quel disco, ci siamo divertiti molto a farlo. Abbiamo inciso una canzone di JJ Cale e Sonny Landreth è venuto a suonare qualche brano, avevamo la sua “Congo Square” …c’erano grandi canzoni, molto stimolante. John era davvero bravo ad orchestrare tutto. Credo che abbiamo fatto cose splendide insieme. John è stata un’altra scuola, un grande insegnamento, anche se molto diverso da Albert. John era sempre in anticipo. Mi diceva, “cinque minuti prima dell’orario significa essere in orario”. Si prendeva cura di tutto.
Mi ricordo una volta, tra l’altro credo fossimo proprio in Italia, in un posto sul mare Adriatico, dopo tre o quattro settimane di concerti, senza day off, sei o sette concerti a settimana o se c’era un day off era di viaggio. E come fanno di solito i musicisti, ci stavamo lamentando, sai quando non c’è lavoro ci lamentiamo e quando ne abbiamo diciamo subito, “Oh mi serve una pausa!”. Così abbiamo detto, “John, dovremmo avere un day off qui”. E John, “non vi ho portati qui in vacanza, siamo qui per lavorare. Vi dirò una cosa. Vi farò lavorare sodo e guadagnare un po’ di soldi. Potete restare qui o tornare a casa, andare a prendere le vostre ragazze e portarle in vacanza. Ma io sono qui per lavorare. E abbiamo un lavoro da portare a termine.” E aveva ragione. Smetti di lamentarti, le cose ti girano bene al momento. John sapeva quello che voleva e non lasciava che nessuno lo ostacolasse o lo fermasse. Questa è stata un’altra lezione. Sono stato molto fortunato ad avere avuto una esperienza personale con queste persone. Io e Walter Trout ne parliamo spesso. Eravamo al posto giusto al momento giusto. Abbiamo avuto una formazione straordinaria da loro, su molti piani, non solo per la musica, ma per la vita.
Matteo Bossi

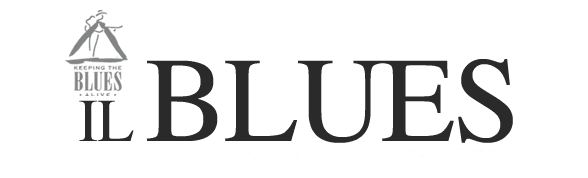











Comments are closed